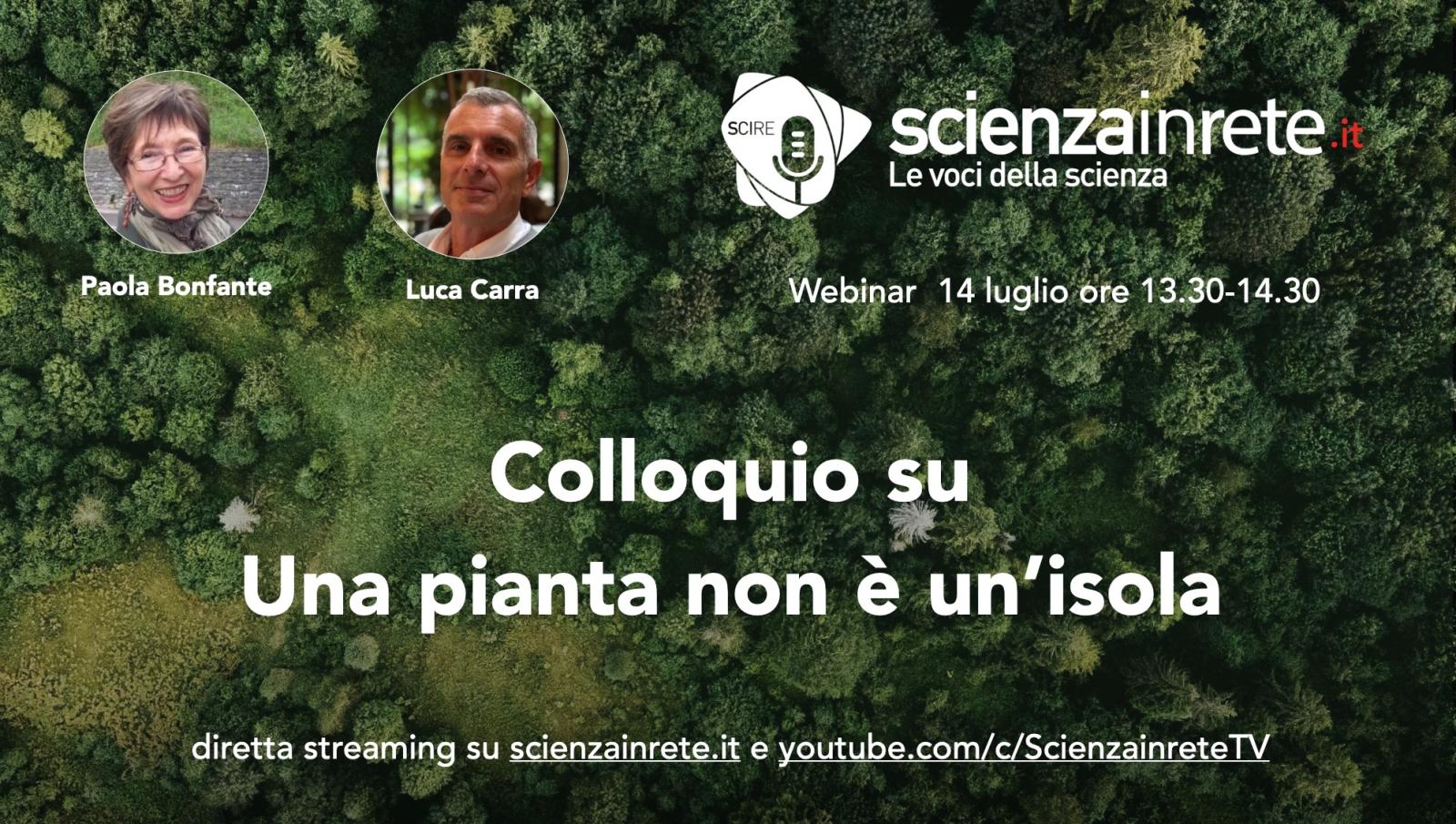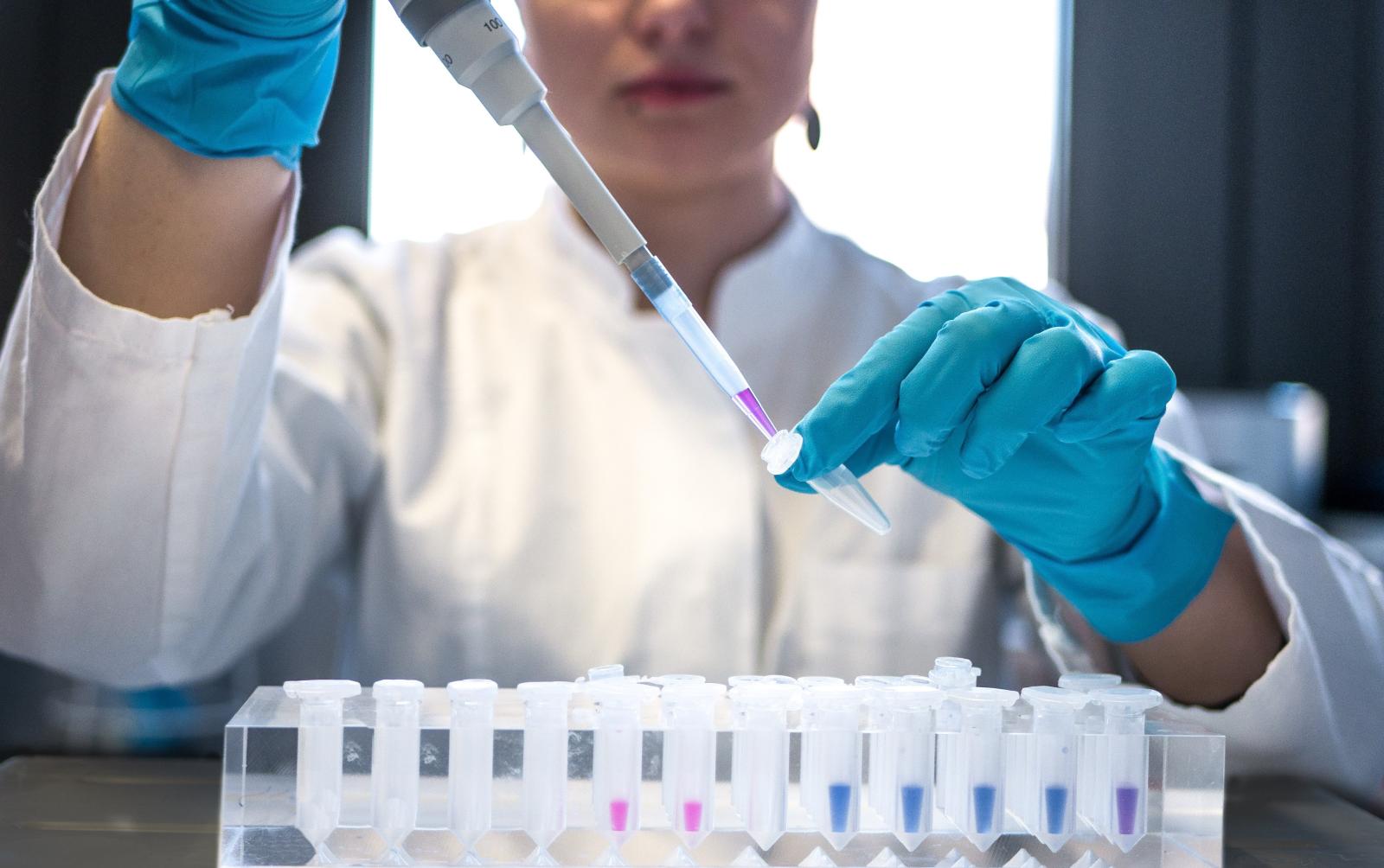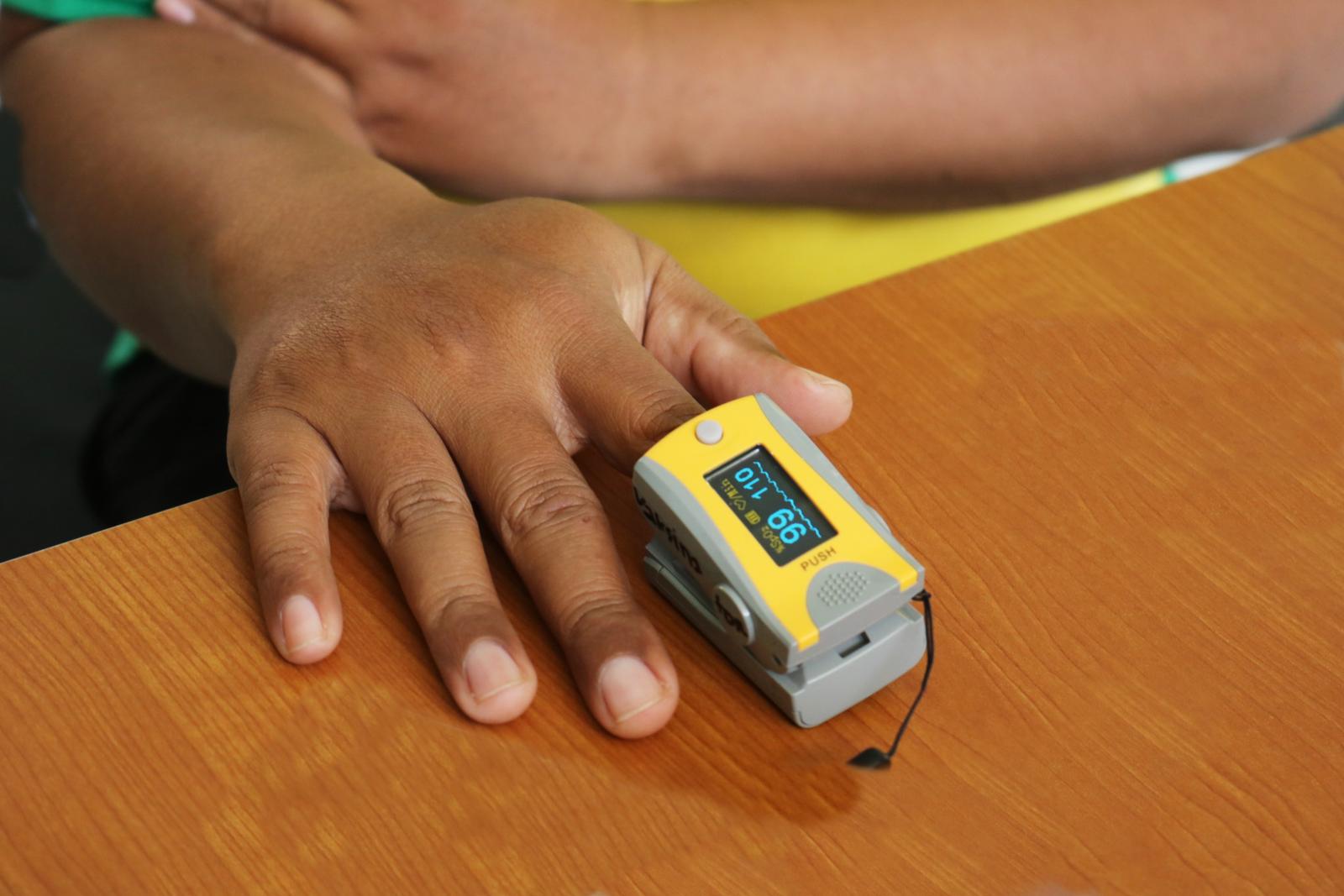La chimica a portata di mano

La chimica nel monolocale, di Stefano Cinti, è una raccolta di brevi articoli o post che forniscono una base di cultura generale per la chimica, trattando i temi più disparati: dalle reazioni che portano alla lievitazione della pizza al perché le mani raggrinziscono in acqua. La recensione di Marco Taddia.
Nell'immagine: alla lievitazione della pasta per la pizza è dedicato il primo capitolo de La chimica nel monolocale. Crediti immagine: Tamara Gak/Unsplash
Per vedere la chimica in azione non occorre andare chissà dove, magari in un grande stabilimento petrolchimico o farmaceutico, in una fabbrica di detersivi o di cosmetici oppure, ancora, in un laboratorio analisi: basta invece guardarsi attorno in casa propria, anche se si tratta di un monolocale. Questa è il tipo di esplorazione che ci propone Stefano Cinti, professore associato di Chimica analitica presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università Federico II di Napoli, con il libro La chimica nel monolocale (tab edizioni, 2022).