“Ogni scienziato ha contratto un debito nei confronti dei propri simili: presentare il frutto dei suoi studi nella forma più chiara, più semplice e più modesta possibile”. Questo pensiero di Karl Popper ispira l'azione del Gruppo 2003 e del suo sito Scienziainrete. Anche la collaborazione con l'editore Dalai nella preparazione della collana Zenit è un contributo in questa direzione.
La collana, che si apre con il volume di Pietro Greco I nipoti di Galileo - storie di scienziati italiani di successo in varie discipline (leggi l'anticipazione)- vuole far conoscere i protagonisti italiani della scienza a livello mondiale – nonché le conseguenze culturali, sociali, economiche e ambientali delle loro scoperte. Suo obiettivo dichiarato è avvicinare soprattutto i giovani e gli studenti ai nuovi orizzonti della scienza. Ci siamo chiesti come farlo, e abbiamo concluso che per avvicinare i giovani alla scienza serve a poco lamentarsi. Meglio, molto meglio raccontare le storie, le idee e i risultati ottenuti dai nostri colleghi che contribuiscono, in Italia o all’estero, a consolidare l’era della conoscienza.. Anche in un Paese largamente estraneo al metodo e alla cultura scientifica, ci auguriamo che i libri di questa collana contribuiscano a trasmettere il senso di sfida, il fascino e la passione che caratterizzano la ricerca scientifica.
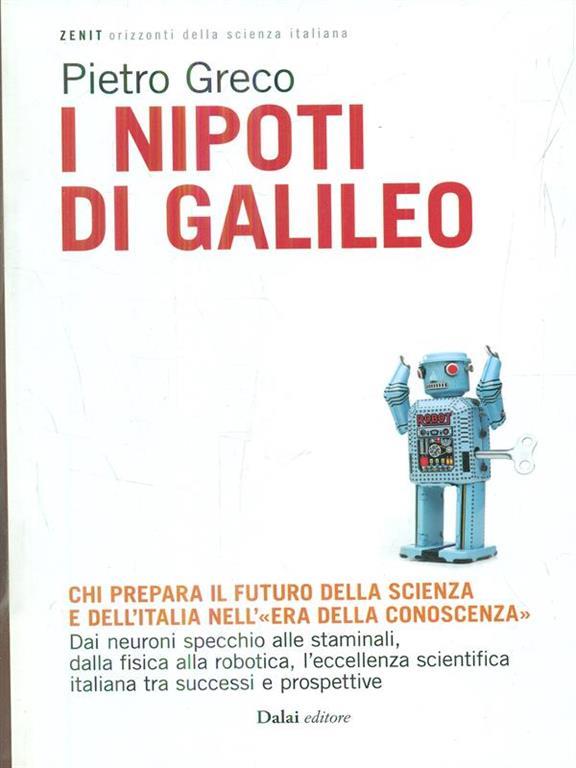
I primi quattro volumi previsti della collana Zenit sono:
I nipoti di Galileo, del giornalista Pietro Greco, storie esemplari di successi scientifici italiani in diversi campi disciplinari, dai neuroni specchio, alle staminali, dalla robotica alla genetica.
I guardiani della vita, di Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas, un quadro per tutti sulle forze segrete del nostro corpo, le scoperte e le prospettive dell’immunologia del terzo millennio (in libreria settembre 2011)
Storia naturale della mente, di Telmo Pievani ed Edoardo Boncinelli, summa delle ricerche degli ultimi anni sul nostro cervello e sulle scoperte che ne spiegano i meccanismi. (in libreria marzo 2012)
La cosa più grande che c’è, di Giulio Tononi e Marcello Massimini, neuroscienziati che hanno sviluppato la Teoria dell’informazione integrata per misurare oggettivamente la capacità del cervello di generare coscienza. I loro studi sono molto conosciuti negli Stati Uniti, dove lavora Tononi (in libreria marzo 2013)
In cantiere per il 2012, vi sono altri due libri in fase di progettazione:
Il primo a firma di Pier Mannuccio Mannucci (direttore scientifico dell’Ospedale Maggiore di Milano) sui danni dell’inquinamento per la salute a livello planetario.
Il secondo di Camillo Ricordi dell’Università di Miami (tra i massimi esperti nel trapianto di “insulae pancreatiche”) sul diabete, le possibilità di cura col metodo Ricordi e le ricadute sociali per i malati.

