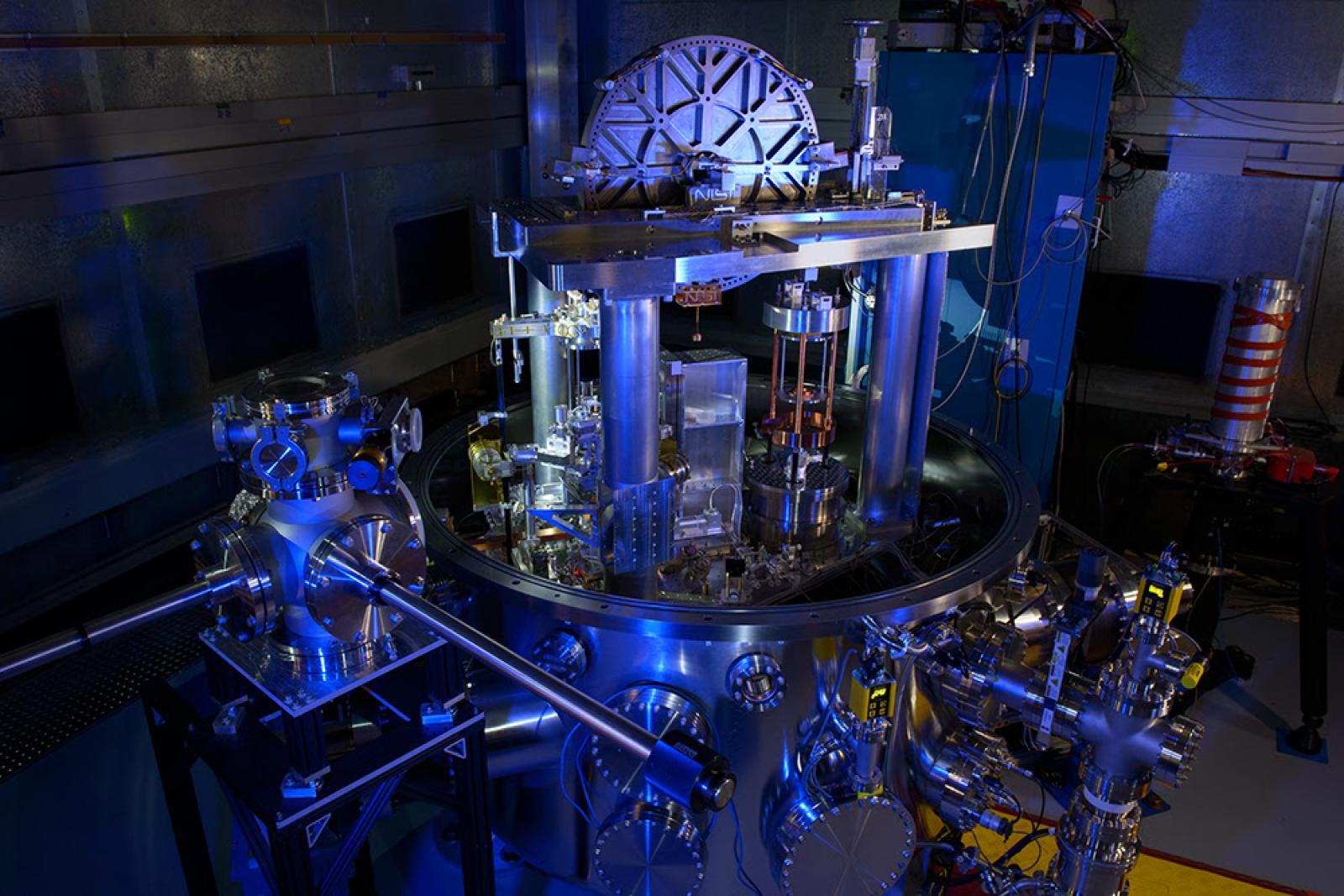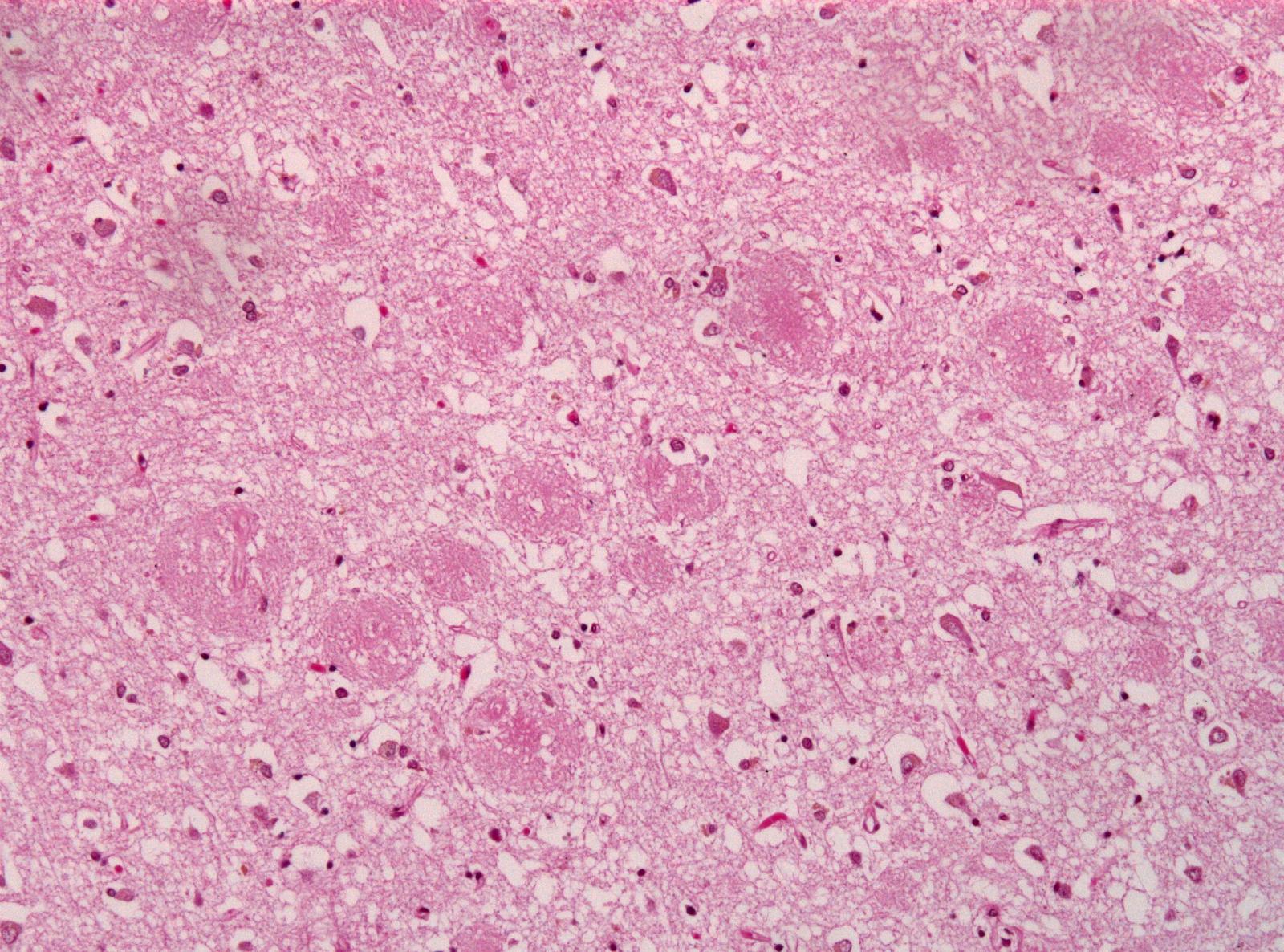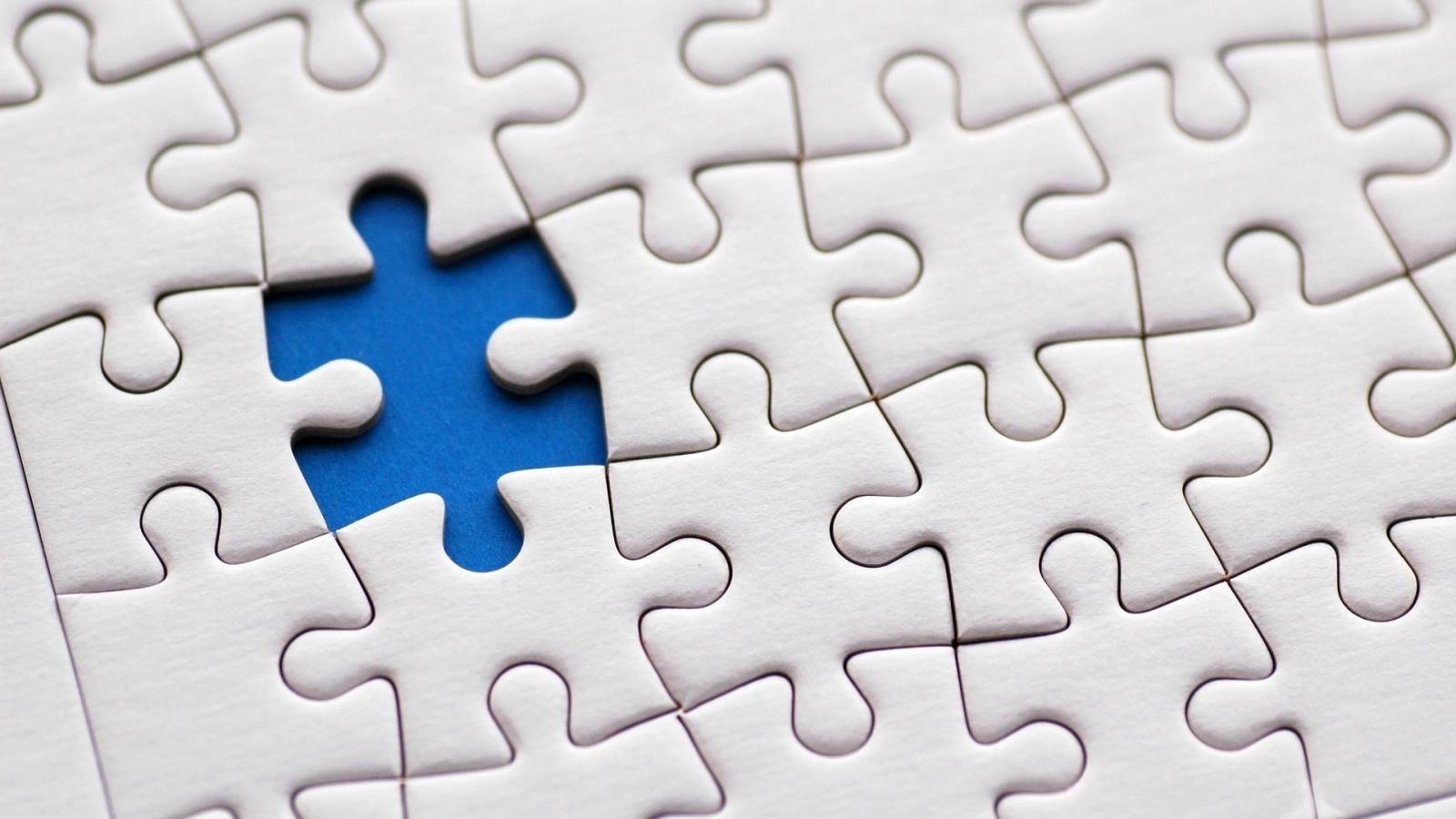Sigarette, e-cig e riscaldatori di tabacco: un dibattito sugli effetti ancora fumoso

Crediti: athree/Pixabay. Licenza: Pixabay License
La dipendenza dal fumo è ancora uno dei problemi di salute globale più urgenti del nostro tempo, con i tratti di una vera e propria epidemia. Le grandi compagnie di tabacco hanno cercato strade alternative alle sigarette tradizionali, aprendo la strada al mondo in continua espansione della sigaretta elettronica e alle soluzioni ibride tra e-cig e sigarette tradizionali. Ma quali sono i rischi di questi prodotti? Ed è vero che fumare poco fa meno male?