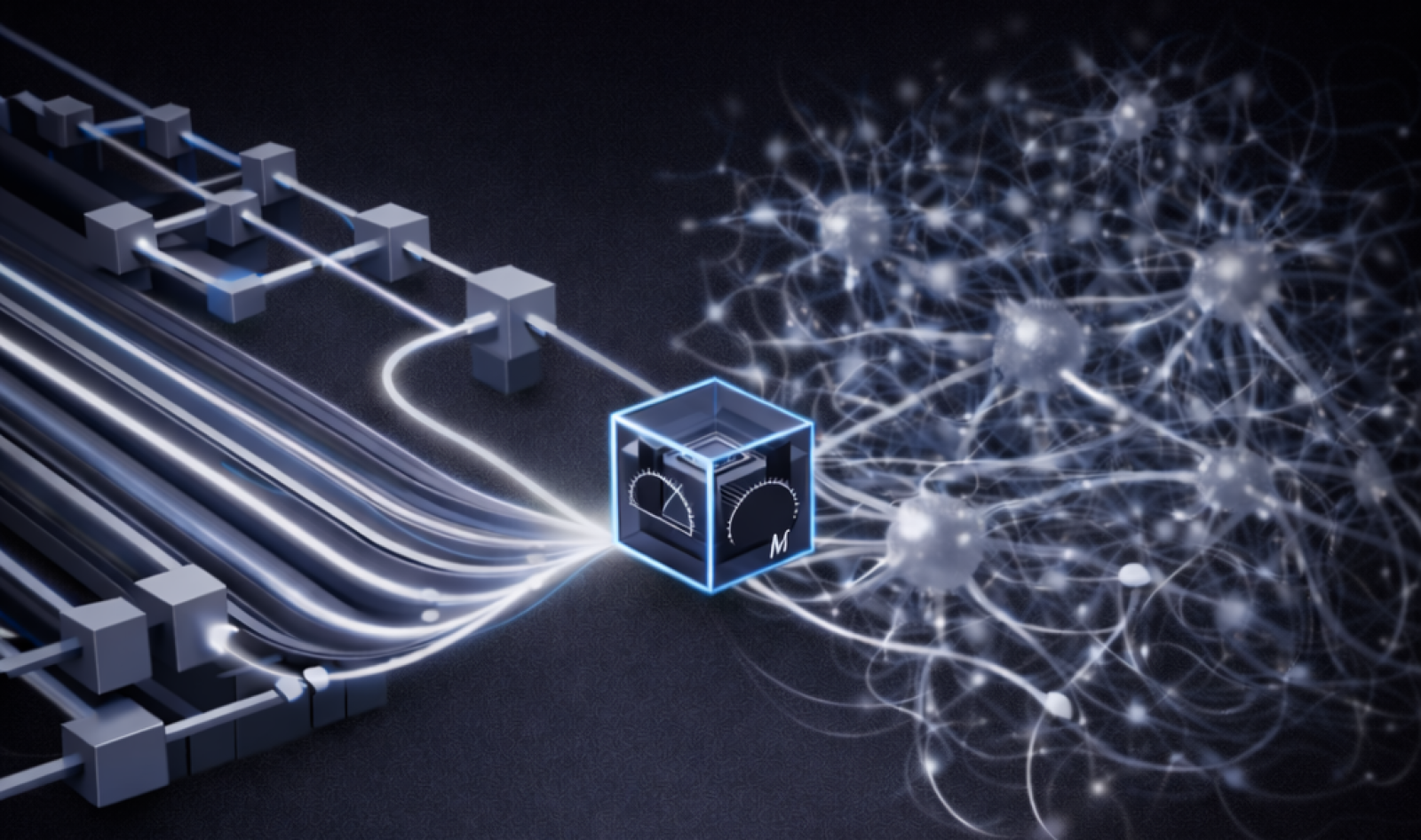Gwendal Uguen, Cybernetic Maelstrom bis, Flickr 2013.
La scienza che, in qualche modo, ha avviato gli studi su quelli che noi oggi chiamiamo i sistemi complessi è certamente la cibernetica, parola che deriva dal greco cubernhtikή, che indica la tecnica, o meglio, l’arte del pilota.
Come disciplina scientifica la cibernetica nasce e si sviluppa tra il 1946 e il 1953, quando la Macy Foundation. chiama a raccolta, a New York, un nugolo di intelligenze di diversa formazione culturale perchè discuta l'impatto che una tecnologia emergente, la tecnologia del computer, potrebbe avere sullo sviluppo delle scienze in generale e delle scienze sociali in particolare. Il piccolo gruppo è costituito da scienziati già molto famosi o comunque destinati a raggiungere presto grande (e meritata) fama. Tra gli altri: John von Neumann, considerato l'inventore del computer digitale e studioso geniale, tra mille altre cose, della struttura logica delle macchine; il neuropsichiatra Warren McCulloch; il biologo e filosofo Gregory Bateson; l'ingegnere Claude Shannon. Ma su tutti si impone, per profondità del pensiero scientifico interdisciplinare, la figura del matematico Norbert Wiener, inventore di quella branca della fisica matematica che si occupa dei processi stocastici e considerato il fondatore della scienza cibernetica.
Bastano le prime riunioni alla Macy Foundation per far emergere chiara la fiducia che hanno quegli uomini, e Norbert Wiener in particolare, nella possibilità di definire, prima o poi, una teoria unificata in grado di spiegare, in termini matematici, il comportamento di sistemi caratterizzati da un numero elevato di componenti e da un intreccio fittissimo di relazioni. Oggi la chiameremmo «teoria unificata dei sistemi complessi».
Norbert Wiener aveva già scritto nel 1943, insieme ad Arturo Rosenbleuth e Julian Bigelow, un articolo in cui proponeva la sostanziale equivalenza tra il comportamento teleologico, cioè finalizzato, degli organismi viventi e il comportamento di sistemi fisici (macchine) capaci di autoregolarsi, mediante quella che egli chiama retroazione (feedback) negativa. Nel 1948 Wiener porterà a maturazione questo pensiero unitario, pubblicando un libro, Introduzione alla cibernetica, in cui, come chiarisce il sottotitolo, affronta i problemi di Controllo e comunicazione nell'animale e nella macchina. L’ipotesi è che non ci sia differenza sostanziale tra organismi viventi e macchine complesse autoregolanti: il comportamento degli uni e delle altre può essere descritto da una medesima teoria. Il mezzo che Norbert Wiener pensa possa portare dritto filato alla nuova teoria unitaria, è quello di allargare, per via rigorosamente matematica, il campo della fisica dal dominio tradizionale della materia/energia a quello nuovo dell'informazione/comunicazione.
E la prima riunione della Macy Foundation offre al matematico il modo di proporre in modo abbastanza esplicito a un pubblico selezionato, ma interdisciplinare, questa ipotesi di ricerca per una nuova teoria unitaria, fondata sul concetto di messaggio, in grado di collegare in un unico ordito teorico la meccanica statistica, l'ingegneria della comunicazione e del controllo delle macchine, la biologia, le scienze della mente e le scienze sociali, fino all'economia.
In breve, Wiener e, in larga parte, i cibernetici sono convinti che in natura «ogni cosa è connessa a tutto il resto». E che proprio attraverso questa connessione olistica, estranea all'approccio tradizionale della fisica, che si concretizza in un intreccio di azioni e di retroazioni (feedback) a causalità circolare, i sistemi complicati e organizzati, siano essi animali o macchine, possono autoregolarsi e sopravvivere nell'ambiente che cambia. Cos'è la causalità circolare? E' presto detto. Per tradizione (e per limiti computazionali), nella scienza e nella filosofia il rapporto tra causa ed effetto preso maggiormente in considerazione è stato quello di tipo lineare. La causa A provoca l'effetto B. B, a sua volta, provoca C. In una catena, sequenziale, di eventi. Facile da immaginare. E facile da trattare matematicamente.
Norbert Wiener pone, invece, l'accento sui sistemi in cui A e B sono, nel medesimo tempo, causa ed effetto l'uno dell'altro. Sistemi cioè in cui l'effetto influenza la causa, attraverso retroazioni o feedback che creano appunto una causalità circolare. Approfondire lo studio, matematico, di queste relazioni causali, attraverso le nuove capacità di calcolo promesse e offerte dal computer, sembra a Wiener il modo per descrivere, contemporaneamente e in qualche modo unitariamente, il comportamento di una macchina, di una cellula, di un'organizzazione sociale.
Con gli occhi di oggi, potremmo dire che i sistemi a causalità circolare, presi in considerazione (ma certo non scoperti) da Wiener, rientrano a pieno titolo in quella gamma, vasta e non sempre ben definita, di sistemi chiamati complessi. Potremmo affermare che il concetto di causalità circolare rappresenta già una buona definizione di ciò che oggi viene chiamata complessità. E che il pensiero di Norbert Wiener e la cibernetica si fondano su un approccio, l’interdisciplinarità, e tre concetti che, sia pure oggetto di controversie, hanno tuttora una profonda influenza su chi studia sistemi complessi: i concetti di olismo, comunicazione, non linearità. D’altra parte Norbert Wiener e la cibernetica rappresentano una delle grandi fonti tradizionali di ispirazione per chi, a partire dagli anni ’80, ha intrapreso lo studio dei sistemi complessi.
In Italia i pionieri della scienza cibernetica sono stati due fisici teorici: Edoardo Caianiello, a Napoli, e Antonio Borsellino a Genova. Con loro la scienza che aspirava a unificare in un comune quadro teorico fisica e biologia, macchine e cervelli ha avuto in Italia un centro di primaria importanza.
Diciamo aspirava, perché la cibernetica non ha avuto i successi sperati e oggi pochi la frequentano. Il suo ciclo di studi sembra essersi esaurito. Ma, a ben vedere, la cibernetica non è morta. Il suo percorso culturale non si è affatto esaurito. La verità è che la cibernetica si è trasformata: ed è diventata parte di studi più generali, che vanno dall’intelligenza artificiale alla complessità, appunto.
Tuttavia, in senso stretto, la scienza cibernetica propriamente detta a un certo punto si arena. Soprattutto a livello applicativo. E per molti motivi. Non ultimo quello di non aver considerato abbastanza complessi i sistemi complessi che voleva studiare. Ma resta, da un punto di vista epistemologico, punto di riferimento importante per chiunque abbia tentato, negli anni successivi, di spiegare in termini unitari le regolarità della natura.
Prima di chiudere il breve discorso sull’arte del pilota che cerca di gettare un ponte tra i diversi livelli di organizzazione della materia, vale la pena rendere un ulteriore omaggio ai pionieri della cibernetica e ricordare, per esempio, che Claude Shannon elabora, nel 1948, una teoria, che si richiama alla termodinamica, considerata ancora oggi il modo migliore di trattare l'informazione, sia a livello applicativo che concettuale. E che John von Neumann risponde nel modo migliore alla originaria richiesta della Macy Foundation, fornendo, presto, la dimostrazione dell'impatto che la nuova tecnologia, il computer, avrà sulla scienza. E persino sul concetto di scienza sperimentale. All'inizio degli anni '50, infatti, mette insieme la bozza di una teoria dei giochi con relativi automi artificiali che rappresentano, forse, il primo esempio che offrono i computer di poter simulare, sulla base di semplici programmi matematici e di una enorme capacità di calcolo, la realtà del mondo naturale. Ma il matematico von Nuemann, come vedremo, dirà la sua anche nell’ambito di quel particolare sistema cibernetico che chiamiamo economia.