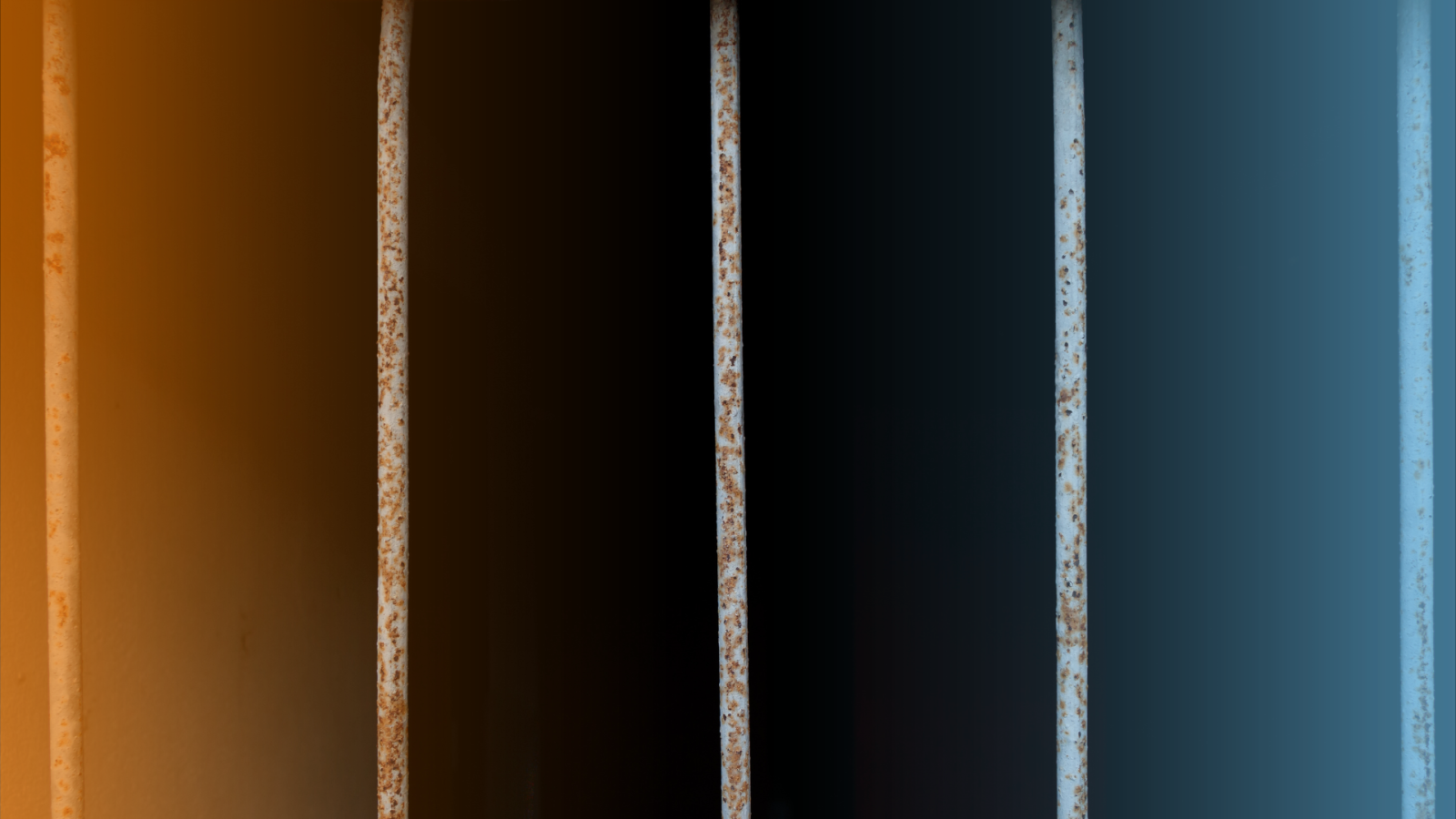Il cambiamento climatico ha catapultato l’Artico al centro
dell’agenda geopolitica mondiale.
Da frontiera inospitale, dove solo la scienza
osava avventurarsi, è diventato terra di conquista. Interessi commerciali,
militari e ambientali si muovono rapidi sullo scacchiere polare, ma tutto
quello che succede lassù avrà un impatto anche quaggiù.
Lassù la temperatura
aumenta a una velocità doppia rispetto
a quella di altre aree del pianeta e le proiezioni dei modelli climatici non
presagiscono nulla di buono. Se nulla cambierà, la temperatura media globale
continuerà a crescere e l’Artico resterà l’area del globo in cui l’aumento sarà
più intenso. La buona notizia, però, è che lassù sta prendendo forma una nuova governance ambientale, frutto dell’incontro
tra scienziati polari e comunità indigene.
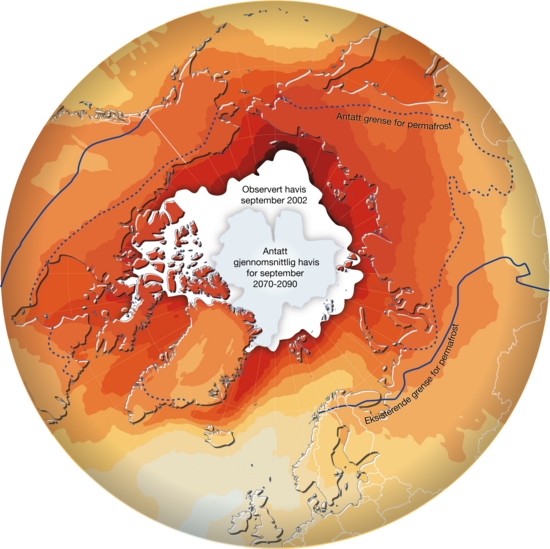
Proiezione dell’aumento delle temperature nell’Artico, 2090 (NCAR-CCM3, SRES A2 experiment). Hugo Ahlenius, UNEP/GRID-Arendal
Il polo Nord, un esempio di scienza partecipata
La presenza della scienza collaborativa nell’Artico risale al 1882, anno della prima edizione dell’Anno Polare Internazionale (la presenza italiana è del 1977 con la Base “Dirigibile Italia”). Al 1882 dobbiamo la prima formale collaborazione scientifica internazionale ai poli: 11 Paesi si impegnano a realizzare 12 stazioni di ricerca nell’Artico e 2 in area subantartica, mettendo in campo il meglio della scienza e della diplomazia dell’epoca.

Le prime 12 Stazioni di Ricerca nell’Artico, 1882 - NOAA Arctic Research Office
L'Antartide era privo di abitanti, ma il Polo Nord ospitava da migliaia di anni una miriade
di comunità indigene distribuite su un territorio di 14 milioni di chilometri
quadrati, 46 volte l’Italia. Oggi il vasto Nord è abitato da oltre 4 milioni di
individui, di cui 500 mila indigeni, incapsulati in realtà politiche e statuali
(Canada, Russia, Danimarca, Stati Uniti, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda
) in cui spesso non si riconoscono e dalle quali sono stati a lungo
marginalizzati.
A causa
dell’eccezionale aumento della temperatura, gli indigeni sono i primi a
soffrire più intensamente il cambiamento climatico, perché la loro sussistenza
dipende quasi totalmente dall’ecosistema artico. La tutela dell’ambiente è
pertanto la loro principale preoccupazione. Era
inevitabile che scienziati polari e comunità indigene si incontrassero. Ma
l’incontro non è stato semplice e nemmeno rapido.
È durato poco
più di cent’anni durante i quali – semplificando – la comunità scientifica
occidentale ha dovuto fare i conti con due guerre mondiali e una Guerra Fredda.
Un successivo lungo periodo di pace e
la caduta della Cortina di Ferro hanno rilanciato la ricerca collaborativa
nell’Artico che oggi muove lentamente verso un nuovo paradigma di ricerca,
quello che alcuni scienziati polari hanno definito new northern research paradigm.
Non
più un paradigma orientato solo alla collaborazione formale con i propri pari
di altri Paesi (più raramente a quella informale con le comunità indigene).
Bensì un paradigma che preveda una maggiore collaborazione con gli indigeni e
un approccio più coerente con i loro bisogni.
le narrazioni indigene possono dare il loro più prezioso contributo
Sul versante
indigeno, nascono e si sviluppano a partire dagli anni ’70 e ’80 movimenti
indigeni di autodeterminazione che decollano a partire dagli anni ’90 grazie
anche all’uso delle nuove tecnologie. La rapida adozione di strumenti Web 2.0
consentono ai movimenti indigeni di comunicare direttamente con la società civile
occidentale e le istituzioni internazionali, bypassando i propri governi di riferimento. Oggi rappresentanti indigeni
del nord siedono ai principali tavoli internazionali sul cambiamento climatico
tra cui il Consiglio
Artico e l’Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC).
Con il nuovo
millennio gli scienziati dell’IPCC si accorgono che le narrazioni indigene sul
cambiamento climatico nell’estremo nord, coincidono perfettamente con i
risultati delle loro misurazioni strumentali (Quarto rapporto IPCC, 2007). Da allora il Panel coinvolge attivamente
rappresentanti di organizzazioni indigene nella realizzazione dei rapporti di
valutazione. “Abbiamo archiviato 140 ore di
interviste a indigeni Saami registrate su videocassetta, centinaia di registrazioni
audio in mp3 e circa 25’000 altre risorse tra immagini e materiali grafici”
confida Tero Mustonen, presidente di Snowchange, un’organizzazione scientifica
e culturale nata in Finlandia nel 2000 proprio per documentare le osservazioni
indigene sui cambiamenti climatici nell’Artico.
Questi e altri materiali sono stati condivisi con la comunità scientifica internazionale, “Molte di queste narrazioni sono oggi parte dell’Arctic Climate Impact Assessment che sono confluite nel Quarto rapporto dell’IPCC. L’anno scorso, invece, siamo stati chiamati a revisionare la bozza preliminare dedicata alla mitigazione del Quinto rapporto IPCC” conclude Mustonen. “Oggi gli scienziati polari possono contare su una miriade di dati, è vero, ma le regioni più remote dell’Artico sfuggono totalmente o in parte all’osservazione scientifica, e proprio qui le narrazioni indigene possono dare il loro più prezioso contributo” spiega Clarence Alexander, co-fondatore del Consiglio Intertribale del Distretto dello Yukon, Alaska, e fondatore nel 1993 di una radio nativa, la KZPA . Registratori acustici subacquei, palloni aerostatici, anemometri, spettrofotometri, droni e quant’altro raccolgono dati su dati. I droni arrivano là dove l’uomo non può, lo stesso vale per i palloni aerostatici ma, né gli uni né gli altri, stanno raccogliendo dati da migliaia di anni. È quello che fanno gli indigeni del Polo Nord.
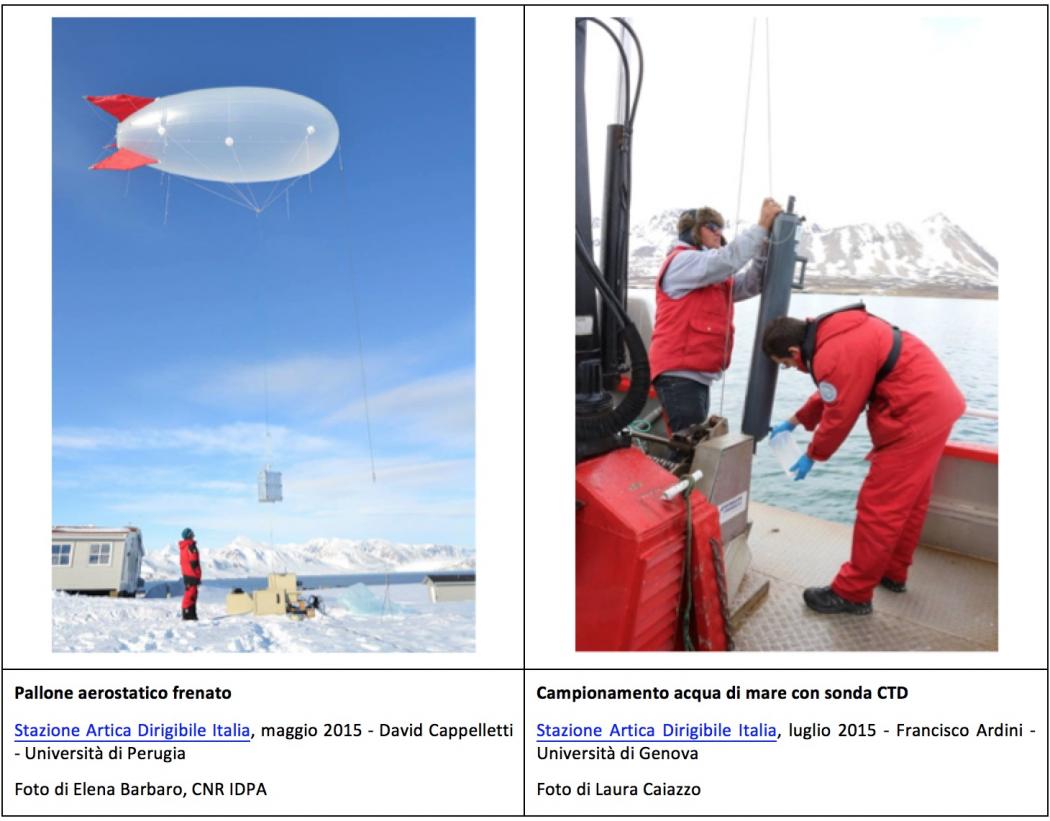
Questi indigeni posseggono una vasta conoscenza sulla
sostenibilità delle risorse locali, sulle variazioni dell’ambiente che li
circonda e sulle pratiche per farvi fronte. Una conoscenza accumulata nel tempo
e tramandata di generazione in generazione per comprendere e prevedere la
natura da cui dipendono.
L’avvicinamento è compiuto e le
due conoscenze sembrano integrarsi. Ma non è così. “La mia attività di ricerca si
svolge prevalentemente su piattaforme aeree in un’area della Groenlandia dove è
molto raro incontrare indigeni” fa notare uno scienziato polare che si occupa
di chimica atmosferica che conclude “Difficilmente un indigeno ha conoscenze di
chimica che io possa integrare nel mio lavoro”. Un collega ammette “È
interessante mettere in relazione la conoscenza indigena con le conoscenze
fisiche” ma aggiunge “Può essere di grande beneficio per tutti i partner sempre
che non violi le componenti scientifiche occidentali”. E qui sta il pomo della
discordia. “Le narrazioni dei popoli
indigeni dovrebbero essere accolte dalla comunità scientifica senza pregiudizi,
invece non vengono accettate perché non sono pubblicazioni sottoposte a
valutazione tra pari” sottolinea Mustonen, e aggiunge, “In questo modo il contributo
delle comunità indigene va perduto, arrecando un enorme danno non solo alle
comunità indigene dell’Artico, ma anche dell’intera popolazione del Pianeta che
ben presto dovrà fare i conti con gli stessi sconvolgimenti climatici” e
conclude “La conoscenza tradizionale indigena è differente, ma è del tutto
legittima”.
Complica il quadro il fatto che
l’agenda di ricerca è stabilita prevalentemente al di fuori delle comunità, che
per questo si sentono escluse, nuovamente marginalizzate.
Eppure le
cose si stanno muovendo. La complementarietà fra la narrazione indigena e
quella scientifica è ormai riconosciuta in letteratura e questo apre a svariate
possibilità di collaborazione reciproca, pur riconoscendo che molti problemi
restano sul tappeto.
Sul versante occidentale, Ellen Bielawski,
professoressa della Facoltà di Agraria e Scienze ambientali dell’Università di
Alberta, Canada, sostiene che la scienza
polare, pur fermamente ancorata alla tradizione intellettuale occidentale,
differisce in molti aspetti dalla scienza geograficamente, finanziariamente e
culturalmente più vicina alle sue basi di appoggio. La scienza artica è
plasmata dall’ambiente, dalla storia, dalla politica e dall’umanesimo. E conclude
“La ricerca artica, lo si voglia o meno, è influenzata dal contesto sociale in
cui viene svolta”. Se l’intuizione di Bielawsky è corretta l’integrazione tra
questi due sistemi di pensiero può avvenire.
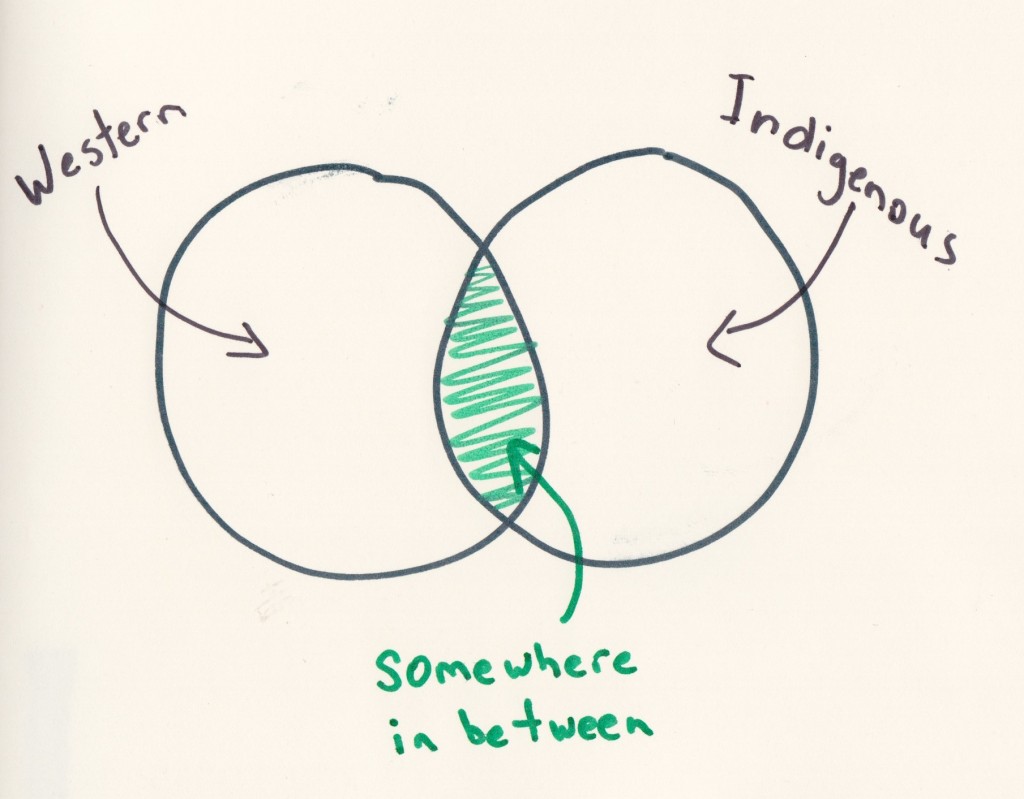
Integrated thought? Aprile 2012, disegno di Salmon Guy
La complementarietà fra la narrazione indigena e quella scientifica è ormai riconosciuta in letteratura e questo apre a svariate possibilità di collaborazione reciproca, pur riconoscendo che molti problemi restano sul tappeto.

Scioglimento del ghiaccio, Ny Ålesund, Isole Svalbard, agosto 2014 - Foto di Peter Prokosch
Buona parte della conoscenza occidentale sul cambiamento
climatico ha una dimensione globale o macro-regionale, quella delle comunità
indigene è per sua natura estremamente locale. Integrare la conoscenza locale a
quella globale e macro-regionale può restituirci più conoscenza e questa sarà più utile per disegnare efficaci piani
di adattamento al cambiamento climatico.
L’integrazione di saperi può contribuire a definire un nuovo e
forse più efficace approccio al cambiamento climatico.
L’Artico è una regione
unica, molto dinamica che - anche grazie al ruolo delle popolazioni indigene e
della scienza polare - può generare meccanismi di governance ambientali del
tutto nuovi che potrebbero essere applicati ad altre aree del pianeta, da altre
comunità locali.