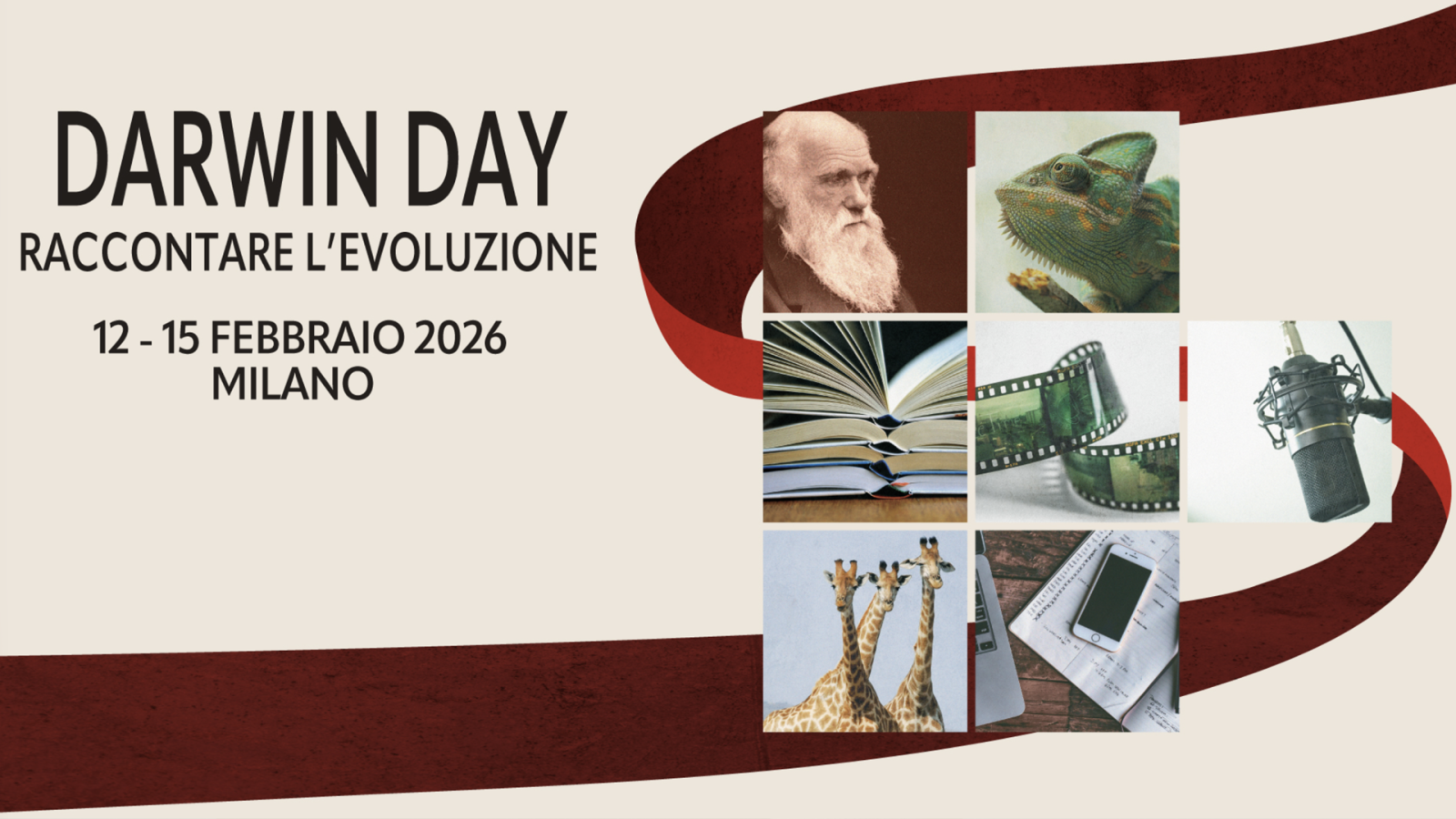“La malinconia del mammut. Specie estinte e come riportarle in vita”, di Massimo Sandal, ci parla di perdite, passate e presenti; e parla quindi del nostro rapporto con l’ambiente, nel quale gli effetti delle azioni ricadono anche sulla nostra specie.
Crediti immagine: Background photo created by rawpixel.com - www.freepik.com
Ci stiamo mangiando la Terra viva. Se la Morte è rappresentata come la signora con la falce, noi siamo le scimmie con la falce, che tagliando il grano portano con sé anche il resto dei viventi
Scrive così il biofisico e giornalista scientifico Massimo Sandal nel suo libro “La malinconia del mammut. Specie estinte e come riportarle in vita” (Il Saggiatore, 2019). Perché parlare di estinzioni in epoca di pandemia? La risposta, abbastanza semplice, è che parlare di estinzioni oggi significa parlare del nostro rapporto con l’ambiente – non solo il rapporto attuale, ma anche quello di ieri e dell’altro ieri e, in effetti, quello che abbiamo instaurato con la natura praticamente nel momento in cui la nostra specie ha fatto la comparsa sul pianeta. È lo stesso filo che ci lega alla comparsa di nuovi patogeni, alla perdita di piante e animali, alla diffusione di altri.
Da ieri a oggi
Il libro di Sandal inizia dal passato, per quello che possiamo ricostruire (che non è poco) delle grandi sparizioni avvenute in epoche remote, a partire da quando l’ossigeno prodotto dai primi cianobatteri avvelenò tutti gli organismi che non riuscirono a trovare un rifugio ipossico o a sviluppare le strategie per sfruttare questa nuova presenza. Arriva al presente e guarda al futuro prossimo, quello che ci si prospetta, sempre più, povero di specie. Solo che stavolta, si potrebbe dire, i cianobatteri siamo noi. O, per usare le parole di Sandal:
Chiunque oggi si domandi come possa l’umanità non vedere davanti a sé il precipizio in cui si sta gettando, si ricordi dei cianobatteri, di come loro e noi seguiamo lo stesso algoritmo darwiniano, antico di miliardi di anni, eppure sempre attuale
Conosciamo i danni che infliggiamo all’ambiente: crisi climatica, deforestazione, urbanizzazione sono da soli una minaccia per gran parte delle specie; se si aggiunge anche il commercio di animali e piante selvatici (vuoi per la carne, vuoi per la medicina tradizionale, vuoi per l’oggettistica o per il commercio come pet), non c’è troppo da stupirsi se i numeri registrati dagli scienziati mostrano declini precipitosi, con un milione di specie, comprese alcune domestiche, a rischio di estinzione, secondo l’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E nel frattempo, come Scienza in rete ha già scritto in diverse occasioni, è un virus (e neanche il primo) a ricordarci che questi danni inflitti all’ambiente sono un’arma a doppio taglio, e che le conseguenze possono ricaderci addosso.
L’estinzione per cui esultiamo
Si pone, qui, un aspetto che ha del paradossale e che Sandal non manca di ricordare nel suo libro: ci sono anche i casi in cui le estinzioni vengono applaudite. La ricerca di un vaccino contro SARS-CoV-2 oggi sta coinvolgendo laboratori di ricerca in tutto il mondo, con una mai vista condivisione delle conoscenze per sterminare un virus che ha appena fatto la comparsa tra noi. Come ricordava poco tempo fa Stefania Salmaso, non sappiamo quando il vaccino arriverà, né quanto sarà efficace, o quanto a lungo ci potrà proteggere dall’infezione. Ma immaginandolo perfetto, in grado di prevenire completamente il contagio, e immaginando anche di poterlo distribuire ovunque, quel vaccino sarebbe di fatto un’arma di distruzione di massa, come lo è stato quello contro il vaiolo, come lo è stato quello contro la poliomielite, che proprio quest’estate è stata dichiarata eradicata dall’Africa.
Certo, parliamo di virus, “oggetti biologici” che non riescono a rientrare in toto della categoria dei viventi, e soprattutto di patogeni. Un virus, peraltro, può offrire la possibilità di essere conservato in laboratorio e sopravvivere ibernato, cosa un po’ difficile da immaginare di fare, per esempio, con una popolazione di rinoceronti. Eppure vale la pena notarlo, perché la ricerca per la prevenzione di malattie non coinvolge solo virus ma anche, per esempio, nematodi (Sandal cita Dracunculus medinensis, il verme responsabile della dracunculiasi) o protozoi come quello della malaria. Viventi a tutti gli effetti, dei quali la nostra salute non sentirà certo la mancanza ma che “sono esempi dell’evoluzione tanto quanto un brontosauro o una sequoia”; patogeni, sì, ma che sono ancora poco noti dal punto di vista biologico, o sfruttano vettori che hanno un ruolo ben noto nell’equilibrio ecologico. Scrive Sandal:
La nostra guerra contro il vaiolo, Dracunculus o le zanzare può sembrare eccezione, una parentesi con regole diverse dal resto della sesta estinzione. Non lo è. Noi portiamo all’estinzione specie a migliaia per il semplice motivo che competono con noi
Scelte
E questa non è una giustificazione morale bensì una “colpa ineluttabile” della nostra specie. Esiste una redenzione? Forse, in un certo senso, ed è a questa che è dedicata l’ultima parte del libro. La de-estinzione è presente in alcuni progetti scientifici: c’è chi punta al mammut, chi al piccione viaggiatore. Ci ha riportato, per il brevissimo arco temporale di sette minuti, un bucardo, o stambecco dei Pirenei, clonato. Ma, come si chiedono alcuni esperti di conservazione, ha davvero senso dedicare impegno e risorse a riportare in vita un mammut – del quale Sandal s’immagina la solitudine, la malinconia appunto, nel suo essere unico – che potrebbero invece aiutare gli elefanti che ancora abbiamo? Gli avanzamenti scientifici possono contribuire alla conservazione delle specie ma, come avevamo scritto per esempio a proposito del rinoceronte bianco settentrionale, per quelle a rischio le prime linee di difesa sono altre, come la tutela dell’habitat. Ed è forse più giusto indirizzare lì i nostri sforzi.
Nell’estinzione siamo immersi ma non la vediamo, non la percepiamo nella vita di tutti i giorni: al più, potremo notare che ci sono meno lucciole rispetto a quelle che ricordavamo anni fa, ma si sa, un aneddoto non fa statistica. “La malinconia del mammut” offre più domande che risposte, ma sono proprio quelle domande che abbiamo bisogno di farci se vogliamo guardare in faccia la realtà e capire dove vogliamo andare, come vogliamo rapportarci con l’ambiente. E forse, le strategie politiche per il recupero post-pandemico sono una buona occasione di farlo, come suggerisce anche in un comunicato la Convenzione per la conservazione della biodiversità delle Nazioni Unite, che nel frattempo, proprio a causa della pandemia, ha rimandato a maggio la prossima conferenza delle parti per definire il prossimo piano strategico.