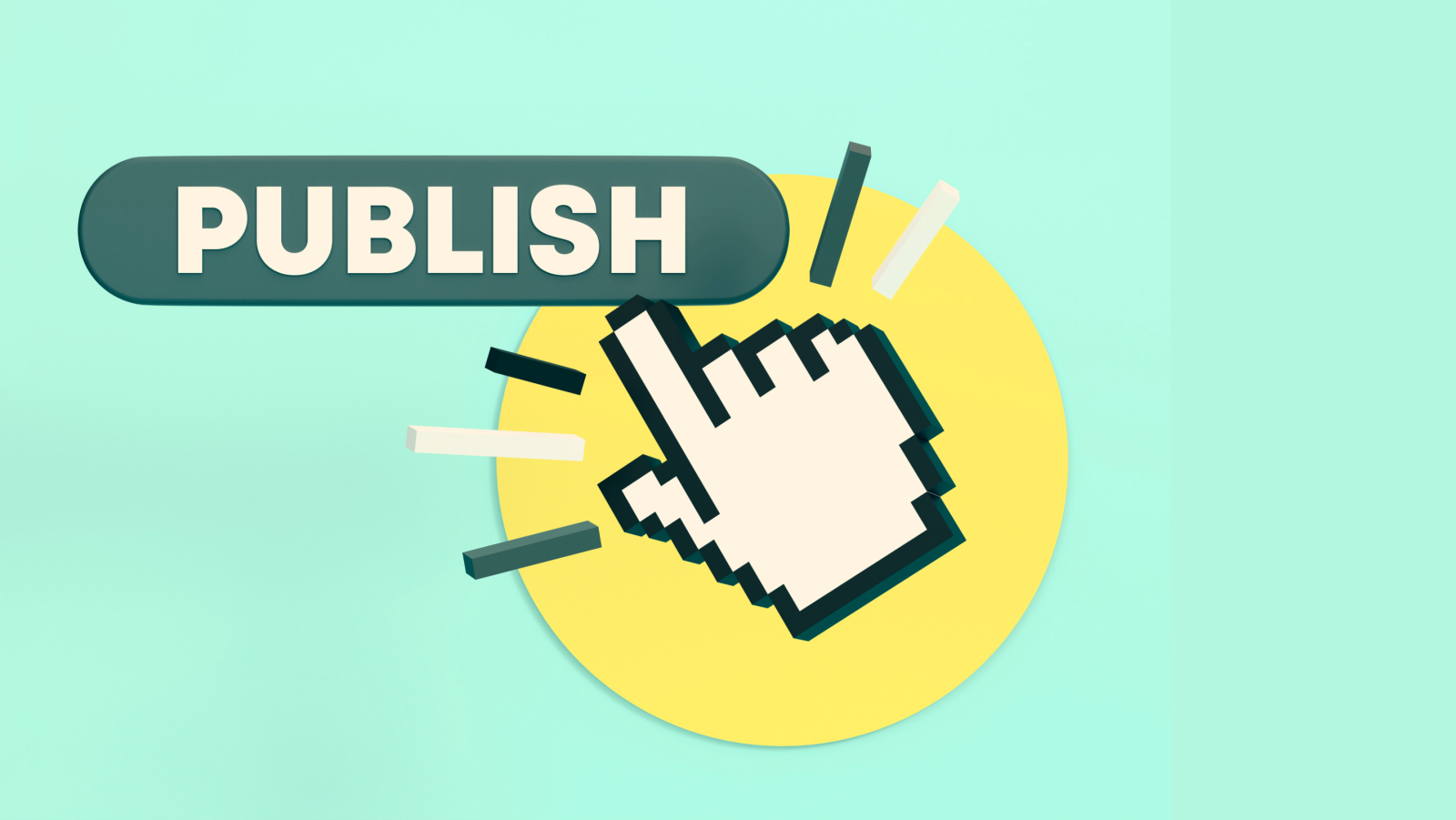L’inglese James Clerk Maxwell è uno dei più grandi fisici di ogni tempo. Per aver elaborato la teoria dinamica del campo elettromagnetico, trovando la spiegazione della profonda identità tra elettricità e magnetismo, e aver dato un contributo decisivo all’elaborazione della teoria cinetica dei gas, con cui la termodinamica è stato di fatto ricondotta nell’alveo del meccanicismo, è degno di stare accanto a Galileo e a Newton, a Einstein e a Bohr. Insomma, accanto ai grandi della fisica di ogni tempo. Tuttavia, come sostiene Giulio Peruzzi, storico della fisica a Padova, forse la sua fama presso il grande pubblico non è pari alla sua effettiva grandezza.
È anche per questo che Giulio Peruzzi ha scritto Vortici e colori (Edizioni Dedalo; pagg. 224;euro 16,00; 2010), un libro che ci porta, con passione e dovizia di particolari, «alle origini dell’opera di James Clerk Maxwell». E alle origini della vita scientifica del fisico nato a Edimburgo il 13 giugno 1831 e morto a Cambridge il 5 novembre 1879 ci sono due lavori per così dire minori (minori rispetto ai due principali): un contributo alla teoria dei colori e un contributo alle meccanica celeste.
Nel primo caso Maxwell si occupa di ottica – seguendo, sostiene, la strada tracciata da Newton – ma anche di percezione dei colori. Sostenendo – intuendo – che i colori, in realtà, sono nella nostra testa. E giungendo ad alcune applicazioni che gli consentono di mettere a punto “il cinema prima del cinema”.
Nel secondo caso Maxwell parte dallo studio degli anelli di Saturno per arrivare a conclusioni sulla stabilità dei sistemi dinamici a più di due componenti. Entrando nel vivo, dunque, dei temi che ancora oggi richiamano l’attenzione dei fisici che si occupano di meccanica.
In entrambi i casi Giulio Peruzzi ci fa vedere – ci fa quasi “toccare con mano” – come opera una mente geniale. Non si limita a fornirci quella che Hans Reichenbach definiva il “contesto della giustificazione”, ma ci porta nel “contesto della scoperta”. E ci offre la possibilità di vedere in azione alcuni strumenti per capire come “lavorano gli scienziati”. Soprattutto in quella fase in cui, per dirla con Albert Einstein, “la scienza sta per nascere”. Ovvero quando lo scienziato, spesso solo con la sua mente, avanza delle ipotesi che poi va a verificare; intuisce delle verità (relative), che poi deve consolidare.
Il tema appassiona lo stesso Maxwell. Che riflette, appunto, sul ruolo che hanno l’immaginazione, le metafore, le analogie in questa fase creativa della scienza. Una fase che ha molte analogie con la creatività dell’artista.
L’altra grande dimensione in cui Giulio Peruzzi ci porta è quello, molto frequentato da Maxwell, “della fertilizzazione incrociata delle scienze”. Di domande e di tentativi di risposte che connettono diverse dimensioni e pongono il tema della interdisciplinarità, fertilizzando appunto ciascuna disciplina. Un tema che poteva essere svolto con una certa naturalezza dai grandi uomini di scienza del XIX secolo, dalla formazione eclettica. Ma che deve essere affrontato con sistematicità scientifica oggi che il sapere disciplinare e la stessa formazione sono sempre più specialistici, mentre molti problemi scientifici emergenti richiedono sempre più la capacità di attraversare gli steccato della specializzazione.