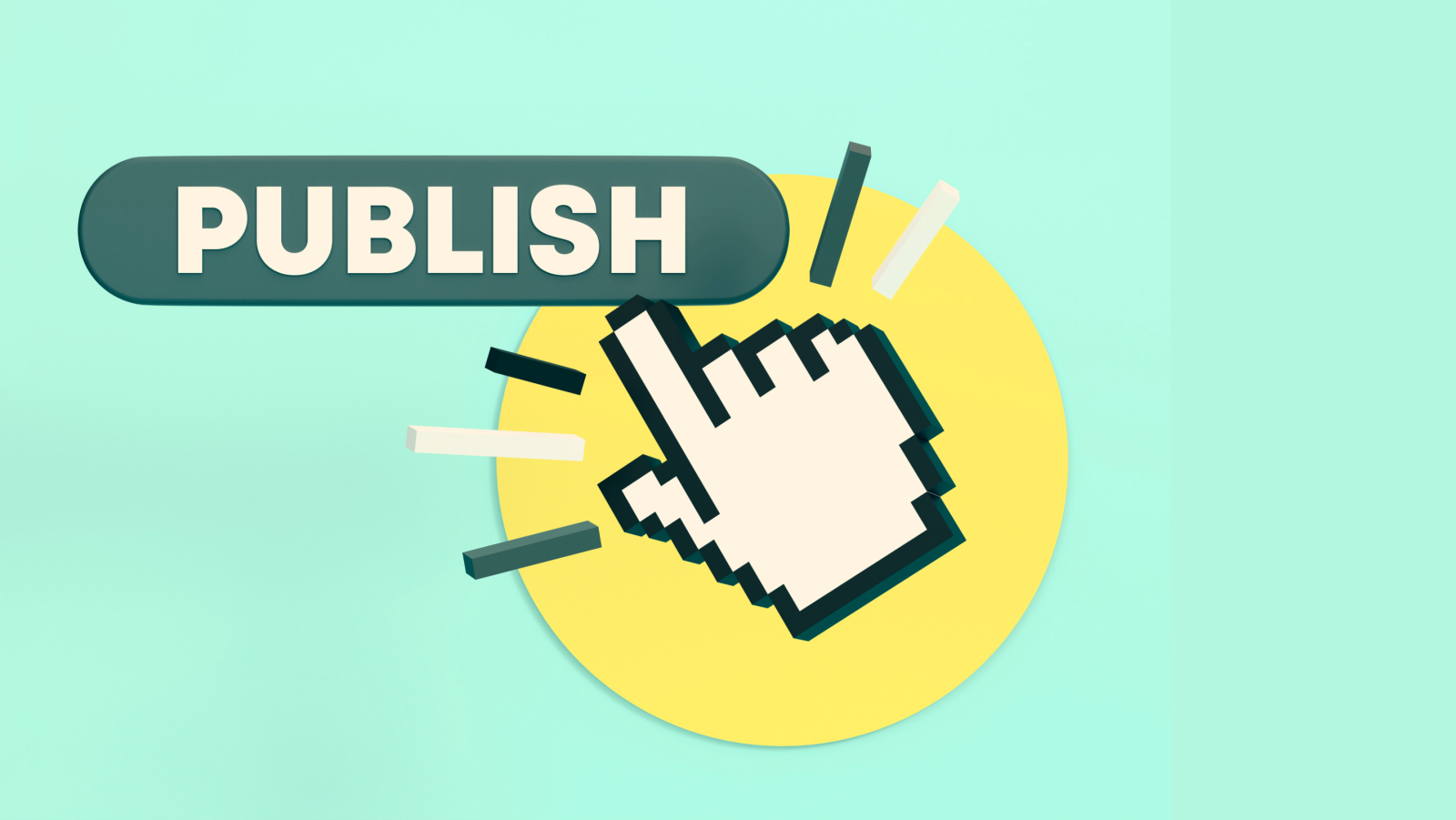Mappata per la prima volta una lastra di ghiaccio in movimento nell’Antartide. Grazie a miliardi di dati acquisiti dai satelliti di ESA (European Space Agency), CSA (Canadian Space Agency) e JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), è infatti oggi possibile monitorare anche le aree che, a causa della limitata apertura visiva di alcuni strumenti, non erano state finora osservate.
Una scoperta importante per la glaciologia, grazie alla quale è possibile ottenere nuove e più dettagliate informazioni circa i movimenti dei grandi ghiacciai e dei loro affluenti, veri e propri fiumi di ghiaccio che si spostano verso l’oceano per migliaia di chilometri. Dati esclusivi in grado di accrescere le conoscenze circa le dinamiche di innalzamento dei mari e il delicato rapporto tra regioni polari e clima.
Envisat, Radarsat e ALOS: questi i nomi dei tre satelliti coinvolti, i cui dati hanno portato all’individuazione di una dorsale che divide i 14 milioni di chilometri quadrati di terraferma da est a ovest nonché di formazioni di ghiaccio in movimento, alla velocità di 250 metri all’anno.
Anche l’Artico è sotto l’occhio vigile dei satelliti ESA: Envisat, CryoSat e SMOS, in grado di acquisire le immagini anche attraverso nubi e in assenza di luce solare, osservano costantemente il Mar Glaciale, rilevando preziose informazioni circa la formazione e lo scioglimento di vaste quantità di ghiaccio galleggianti.
Le ultime misurazioni effettuate da satellite portano all’ipotesi che quest’anno la copertura glaciale nell’Artico sarà al di sotto della media e che il Passaggio a Nord Ovest (la rotta che va dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico attraverso l'arcipelago artico del Canada) si aprirà come accadde nel 2007. Diverse le condizioni meteorologiche attuali rispetto a quattro anni fa, ma l’alta probabilità che questo passaggio possa nuovamente essere agibile è un segnale preoccupante di una più scarsa copertura di ghiacci nella regione.