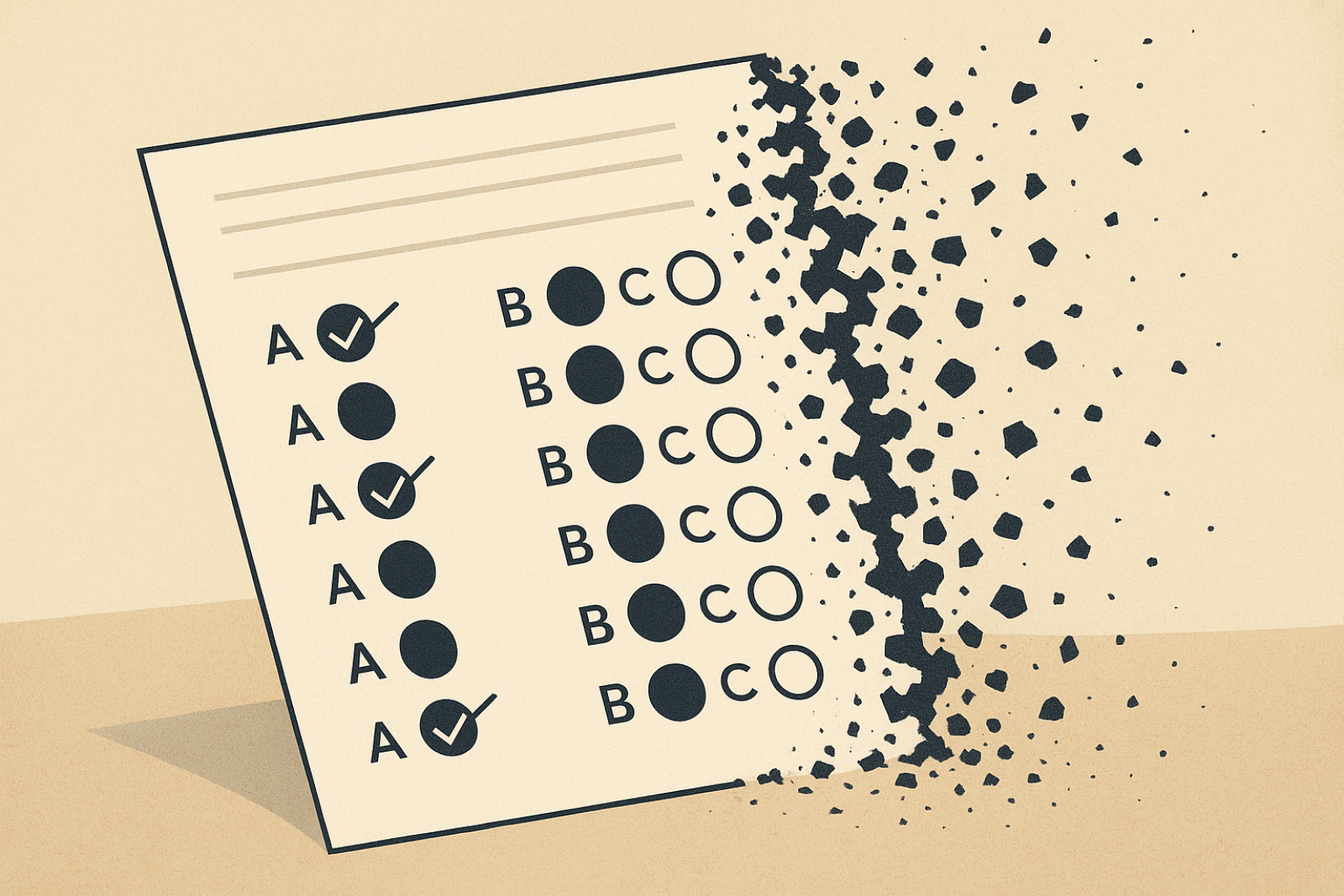
Il nuovo test d’ingresso a medicina, presentato come la fine del numero chiuso, mantiene invece molte delle criticità passate e ne aggiunge di nuove: selezione nozionistica, guerra tra studenti e percorsi stressanti. È una riforma che rischia di compromettere la qualità della formazione medica e la salute pubblica.
Erano numerosi i colleghi che, come il sottoscritto, pensavano non sarebbe stata fatta. Era troppo improbabile e dannoso il piano del governo per riformare le procedure di reclutamento degli studenti di medicina, che percolava nei canali mediatici. E invece eccola, in tutta la sua assurdità e perversione, la riforma dell’ingresso a medicina voluta da una classe politica che conosce un solo principio, quello del marchese del Grillo: «Io sono io e voi non siete un c…o».
Contro il numero chiuso e il test “a crocette” da alcuni anni a questa parte si esprime un numero di politici crescente, via via che le competenze medie dei politici italiani declinano inesorabilmente. Ovvero, via via che aumenta la percentuale di coloro che non hanno frequentato l’università o non hanno idea, né si sono chiesti di come funzioni una facoltà di medicina. Anche medici con indole populista, controriformista o ex-pseudosessantottina hanno criticato le modalità esistenti finora. Che erano pessime, certamente, ma anche le uniche pragmaticamente praticabili in un contesto politico-istituzionale come quello italiano.
Il numero chiuso era stato introdotto in Italia con la legge 264/1999, che stabilì l'accesso programmato per corsi come medicina, odontoiatria e veterinaria, basato su un test nazionale (la Corte costituzionale ne aveva stabilita la legittimità con la sentenza n. 383/1998). Si era reso necessario dopo che nel 1969 l’apertura per tutti i diplomati (fino al 1923 potevano iscriversi solo i diplomati al liceo classico e dal 1923 al 1969 solo chi aveva la licenza classica o scientifica) aveva prodotto l’aumento esponenziale degli iscritti, un sovraffollamento delle aule e lo scadimento della qualità formativa. Nel 1987, il ministro dell'Istruzione Ortensio Zecchino introduceva, tramite decreto ministeriale, un test di ammissione per limitare gli accessi, in linea con le direttive europee che richiedevano standard formativi elevati per le professioni sanitarie.
Come principio, il numero chiuso esiste dappertutto (infatti la riforma non lo può follemente eliminare) ma funziona diversamente nei diversi paesi, a seconda delle visioni politiche, culture o sistemi accademici. È come la democrazia secondo Churchill: il peggior sistema, a parte tutti gli altri. In Italia era poco efficiente, su questo non ci son dubbi. Ma per non farci mai mancare di essere gli ultimi in tutto, siamo riusciti a peggiorarlo.
La riforma andata in Gazzetta il 15 maggio scorso (DL 15 maggio 2025, n. 71) e i cui decreti attuativi sono stati resi pubblici (Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025) è una presa in giro. Quasi sadica. È stata annunciata per togliere il numero chiuso, che invece rimane, e il test a crocette, e anche quello rimane per metà delle domande (l’altra metà circa è a completamento di frasi, che implica diverse procedure cognitive, ma sempre nozionistiche). È stata però creata per gli studenti una valle della morte che dovrebbe portare a una selezione (test nazionale) dopo quattro mesi di frequenza di corsi di fisica, chimica e propedeutica biochimica, biologia. Con la mortale possibilità di riprovarci (a iscriversi al semestre filtro) per tre anni (tre!). Tutti sono preoccupati per la fragilità psicologica dei ragazzi d’oggi, ma poi si gettano almeno 80mila di loro in una guerra di tutti contro tutti, che sarà senza esclusione di colpi. E non prevarranno i più promettenti per motivazioni e razionalità. Se aumenteranno la prescrizione e la vendita di farmaci a base di amfetamina una spiegazione ci sarà.
L’ordine dei medici e tanti professionisti di area medica hanno detto che la riforma disorienterà e penalizzerà gli studenti. Non si sono quasi fatti sentire però quei docenti che si ritengono competenti di pedagogia medica, a fronte di una riforma che fa strame dei presupposti epistemologici conquistati nel corso di un secolo di studi e applicazioni di metodi per migliorare insegnamento e apprendimento della medicina. Una riforma che, appunto, non risolve il problema di come selezionare quelli motivati: come si può facendo studiare per quattro mesi delle materie di base che valorizzano le competenze nozionistiche e certamente non quelle psicologico-morali? Peraltro, mentre i precedenti test provavano, in modi un po’ ingenui, a rilevare negli studenti anche la presenza di un po’ di pensiero critico (con domande di logica e decisioni razionali) e di cultura generale o di attualità, il nuovo test nazionale conterrà e non può contenere che domande a cui si risponde ricorrendo alla memoria.
Tralasciamo la logistica di gestire mandrie di adolescenti in strutture universitarie inadeguate. Ma si potrà ricorrere all’insegnamento a distanza, quindi: o si rischierà comunque l’incolumità in aule sovraffollate e assordanti di chiacchiere o si rischierà di deprimersi in solitudine a casa.
Si potrebbe scrivere un pamphlet, usando questa legge come cartina di tornasole per discutere e denunciare il livello intellettuale e morale sempre più basso verso il quale sta correndo il sistema politico e istituzionale in Italia. Non siamo i soli nel mondo a correre verso qualche precipizio. Ma non dovrebbe consolare. In questo caso, in gioco c’è la salute, e quindi ci sono sofferenze di persone che si aspettano aiuti competenti per curare malattie e alleviare i dolori fisici e psicologici. Nonché le attese di realtà sociali che si aspettano che la medicina continui a migliorare per capacità qualitative e quantitative, cioè che sappia usare al meglio lo tsunami di innovazioni tecnologiche in arrivo, senza che l’aumento dei costi produca ancor più inaccettabili diseguaglianze.
C’è grossa crisi in medicina, direbbe Quelo/Guzzanti. Una crisi persistente che non è dovuta solo alle inadeguatezze delle politiche sanitarie, alle dinamiche socio-demografiche ed economiche della sanità e alle sfide tecnologiche (queste anche sfide positive) che hanno nomi come genomica, organi sintetici, stampa di tessuti 3D, xenotrapianti, innovazione tecnologica, informatizzazione e analisi di dati, IA e robotica... Di fronte a queste sfide si stagliano gravi limiti, che stanno assumendo contorni inquietanti: il crollo delle motivazioni e della qualità della formazione dei medici e l’incapacità dei professionisti e degli esperti di capire e gestire i problemi, esistenti e in arrivo.
Una letteratura, anche empirica, crescente mostra che il declino delle motivazioni dei medici, all’inizio e durante la carriera, è influenzato dall’eccessiva burocratizzazione della professione, con perdita di autonomia: è il fattore principale. A seguire, la difficoltà di governare cognitivamente un carico di dati crescente, le pressioni e la frammentazione che lasciano poco tempo per il rapporto con il paziente, i crescenti attacchi e aggressioni ai medici e operatori sanitari, la perdita di identità etica dovuta alle offese morali per i fallimenti del sistema e il declino delle soddisfazioni intellettuali a fronte degli algoritmi che quasi cancellano i ruoli diagnostici.
Le cause del declino della formazione sono ancora l’esplosione dei dati biomedici, che producono sovraccarico e portano a una memorizzazione superficiale, la burocratizzazione della professione, come la quasi cancellazione dell’insegnamento al letto del malato e della tutorship personale, una perdita di riflessione epistemologica dovuta a un apprendimento meccanico e al ridotto uso di pensiero critico, le pressioni commerciali e tecnologiche che portano a concentrarsi soprattutto sulle procedure, a scapito di una visione complessiva della cura e il burnout dei docenti che sono sempre meno appassionati per l’insegnamento.
Un fattore ulteriore e grave, che nelle cosiddette società della conoscenza svolge un ruolo tragicamente devastante, è la pandemia di overconfidence o eccesso di fiducia tra politici ed esperti, che provano di volta in volta a mettere mano a problemi o sfide che non capiscono e non cercano neppure di capire, studiandole. Professionisti che hanno guidato le facoltà di medicina e coltivato potere a 360 gradi nelle più diverse forme, hanno progettato la riforma credendo di conoscere e poter gestire i problemi senza prendere tempo, studiarli e illustrare ai burocrati ministeriali la tragedia verso la quale si stava andando per mero populismo demagogico.
Inoltre, per un elementare senso etico, potevano non prestarsi. Ma la scelta del potere per il potere è incontrollabile, se non si è imparato a gestirla. Anche questa è una forma di comportamento inconsapevole (più o meno) sostenuto da diversi bias ben descritti in letteratura. Il potere rende difficile vedere i propri limiti, deforma il giudizio morale, induce razionalizzazioni che legittimano la prepotenza e crea resistenze emotive al cambiamento e al confronto critico. E, come diceva Lord Acton, quanto maggiore è il potere che si esercita (e quanto più a lungo lo si detiene) tanto maggiore la corruzione che porta con sé.
Così si producono danni inutili e soprattutto evitabili non a cose astratte, ma a persone.

