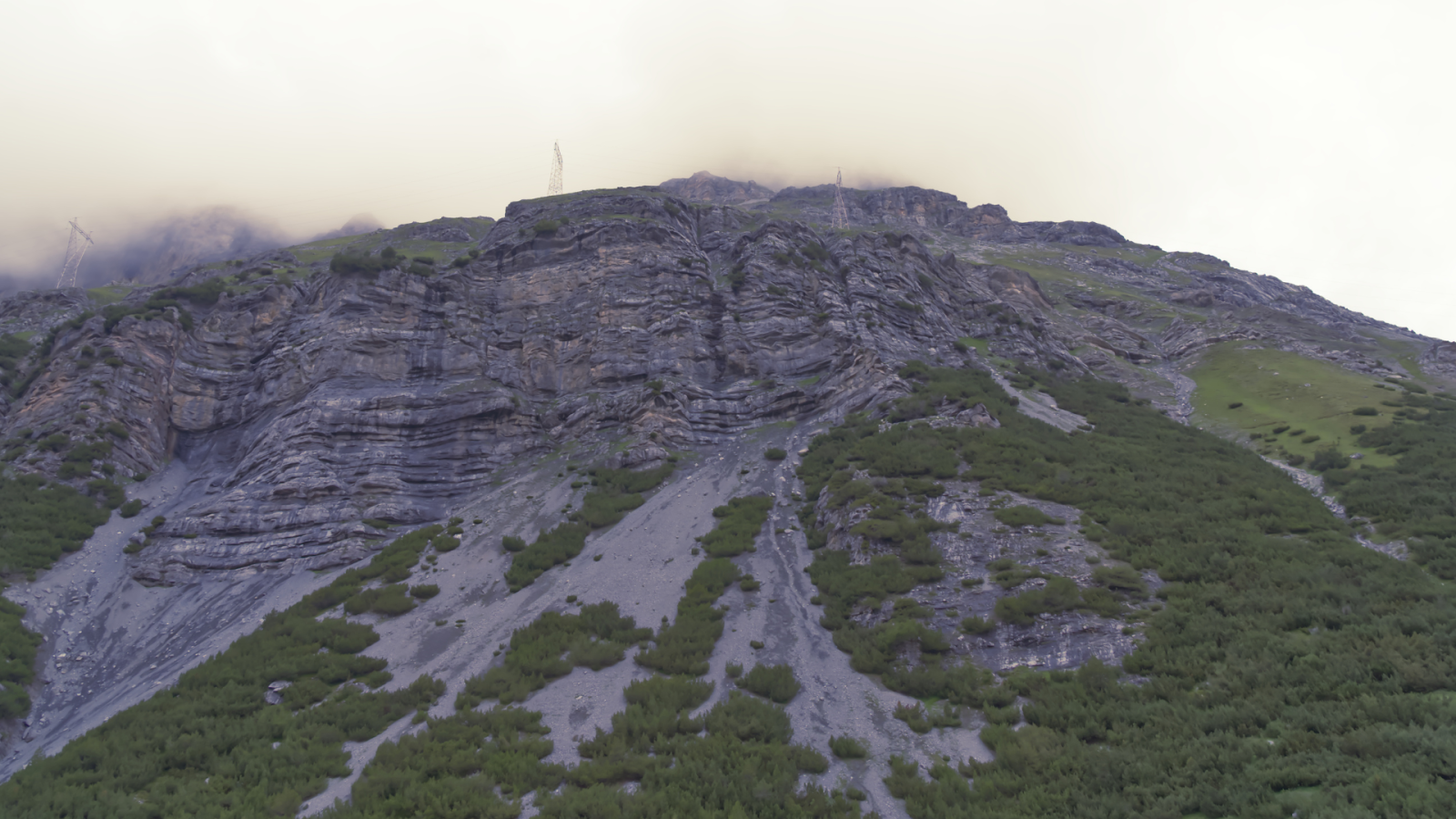È notizia recente (vedere le Breaking news L’arte astratta modifica il cervello) che anche l’arte astratta (oltre quella figurativa) può svolgere un ruolo empatico e esercitare una forma di “potere” sull’osservatore. Studi del genere mancano per le “opere” scientifiche, ma ho l’impressione che la vista di una formala (sia essa matematica o chimica) o di una complessa apparecchiatura scientifica susciti, in genere, nell’osservatore una risposta molto meno emotiva. Noi che assaporiamo l’infinita bellezza di una formula che può racchiudere un intero universo dobbiamo chiederci perché questo effetto emotivo non è generale.
La scienza moderna è sempre più specializzata e legata alla tecnica. Le discipline si dividono in settori, i settori in sottosettori e via di seguito per seguire la strada dell’applicazione immediata. Questo “fatto” ha aspetti positivi e negativi, due facce della stessa medaglia. Se da un lato permette approfondimenti sempre maggiori in campi specifici e applicazioni di uso quotidiano, tale “spezzettatura” rischia di fare venir meno il “quadro d’insieme”, le idee unificanti che, oltre ad avere effetti dirompenti sulle ricerche specifiche, hanno valenza e ruolo culturale. La scienza moderna non può rinunciare a tale ruolo in un mondo plasmato dalle sue applicazioni, in cui tutto la chiama in causa, nel bene come nel male.
Sul versante artistico, il percorso dell’arte pittorica contemporanea ha portato al progressivo annullamento dei canoni fondamentali della pittura tradizionale. Nella storia artistica occidentale, l’immagine pittorica è stata sempre quella di tipo naturalistico, lo scopo quello di riprodurre fedelmente la realtà, di rispettare il principio della verosimiglianza. Questo obiettivo era stato raggiunto con il Rinascimento italiano che aveva fornito anche gli strumenti razionali e tecnici del controllo dell’immagine naturalistica: il chiaroscuro per i volumi e la prospettiva per lo spazio. Dall’Impressionismo in poi, la pittura ha progressivamente rinnegato questi principi, spostandosi su nuovi territori da esplorare. Già Manet aveva abolito il chiaroscuro, risolvendo l’immagine, sia plastica che spaziale, in soli termini coloristici. Alla fine dell’Ottocento, era rimasto da smontare l’ultimo pilastro della pittura tradizionale: la prospettiva. Questo fece Picasso nel suo periodo di attività che viene definito “cubista”.
Picasso portò lo spostamento e la molteplicità dei punti di vista alle estreme conseguenze. Nei suoi quadri le immagini si compongono di frammenti di realtà, visti da tutte le angolazioni e miscelati in una sintesi del tutto originale. Nella pittura tradizionale, la scelta di un unico punto di vista, imponeva al pittore di guardare solo ad alcune facce della realtà, che si presentava di conseguenza come semplice. Nei quadri di Picasso, invece, l’oggetto viene rappresentato da una molteplicità di punti di vista, in un’ottica complessa, ma riuscendo a dare una rappresentazione globale dell’oggetto. Questa sua particolare tecnica, tuttavia, lo portava a immagini dall’apparente incomprensibilità, in quanto risultavano del tutto diverse da come la nostra esperienza è abituata a vedere le cose e ciò nonostante di effetto coinvolgente.
Come si rapporta questa rivoluzione artistica alla scienza? Perché si è detto che c’è bisogno di un nuovo Picasso in scienza che dia anche alle sue “opere” un generale impatto empatico? La mia impressione è che la scienza contemporanea abbia applicato molto bene l’idea di guardare gli oggetti da differenti punti di vista (lo “spezzettamento” di cui si è parlato), ma abbia completamente mancato l’obbiettivo di farne poi una sintesi, una rappresentazione globale della realtà, di trasformare le idee scientifiche in cultura. Ciò è in gran parte dovuto all’eccessivo concentrarsi della scienza sulle applicazioni, sugli aspetti che danno un risultato immediato, dimenticando anche il suo nome. La parola scienza, infatti, deriva dal latino scientia, che significa conoscenza.