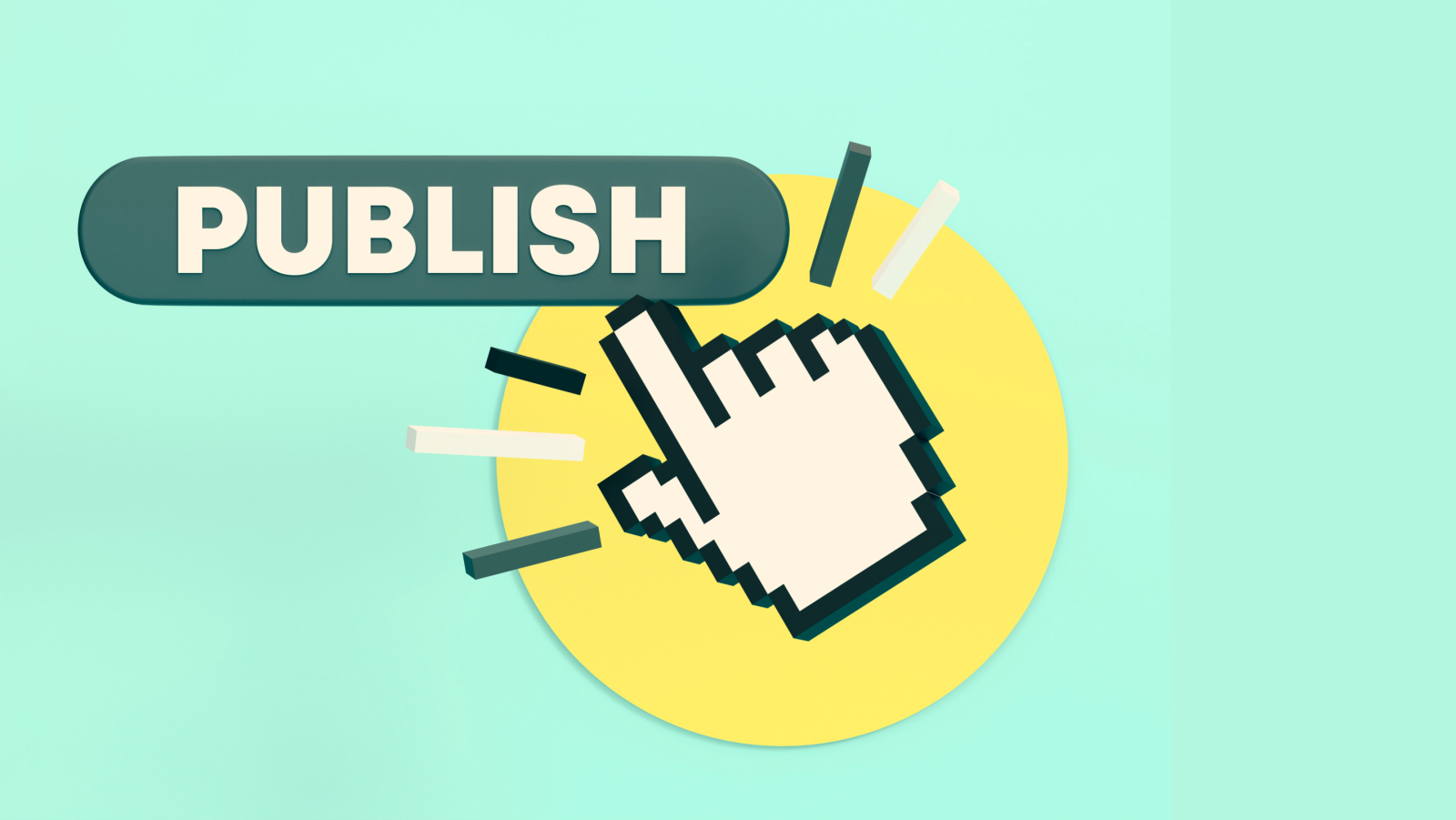I musicisti sono in grado di riconoscere le parole con più facilità rispetto alle persone che non hanno mai studiato musica. A dirlo è uno studio del dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca condotto su quindici musicisti (pianoforte, violino, violoncello, tromba, clarinetto, flauto, organo, composizione, direzione d’orchestra) del conservatorio Verdi di Milano e su altrettante persone con nessuna competenza musicale. La ricerca dimostra che chi è in grado di leggere il pentagramma ha una marcia in più: nel cervello dei musicisti, infatti, si attiva un’area del linguaggio solitamente “spenta” in tutte le altre persone. Lo studio, pubblicato su Neuropsychologia e condotto in collaborazione con il Cnr presso il laboratorio di elettrofisiologia cognitiva dell’Università di Milano-Bicocca, può avere delle applicazioni positive anche nella cura della dislessia.
«È noto che imparare a suonare bene uno strumento musicale - spiega Alice Mado Proverbio, docente di Psicobiologia e Psicologia Fisiologica e coordinatrice dello studio - modifica la connettività cerebrale e la struttura funzionale del cervello - sia a livello di materia grigia che di materia bianca-, velocizzando il transfer inter-emisferico, migliorando il controllo e la coordinazione motoria e l’elaborazione uditiva dei suoni». Il cervello dei musicisti, insomma, è più smart.
«Noi abbiamo dimostrato che il cervello dei musicisti che hanno iniziato a studiare musica da piccoli, entro gli 8 anni, è anche più velocenel riconoscere le parole – continua la professoressa Proverbio. Per farlo, abbiamo confrontato l'elaborazione visiva delle note e delle parole in 30 persone destrimani, registrando la loro attività bioelettrica sincronizzata (ERP) in risposta a parole e note in un pentagramma».
I ricercatori hanno scoperto che studiare musica da piccoli modifica i meccanismi neurali di lettura delle parole, qualunque sia lapredisposizione genetica delle persone. Mediante l’applicazione di una tecnica di neuroimmagine elettromagnetica è stato osservato che durante l'analisi di simboli alfabetici le persone prive di conoscenze musicali attivavano solo la regione per le parole (detta anche visual word form area, situata nel giro fusiforme della corteccia occipito/temporale, BA37) e il giro occipitale inferiore di sinistra (BA18), mentre nei musicisti queste regioni si attivavano su entrambi gli emisferi, raddoppiando il volume corticale impegnato. Per la comprensione simbolica delle note è infatti necessaria una raffinata analisi spaziale di tipo globale in cui eccelle l’emisfero destro.
I musicisti, a differenza delle altre persone che si sono sottoposte all’esperimento, utilizzavano dunque le cortecce visive di entrambi gli emisferi cerebrali, dando vita a un meccanismo neurale in parte comune per l’analisi delle parole e delle note nel pentagramma. «L’evidenza che il meccanismo neurale di elaborazione delle lettere differiva per musicisti dalle persone che non conoscono il pentagramma – conclude la professoressa Proverbio - dimostra come il training musicale precoce modifica i meccanismi neurali di lettura. Questi risultati possono avere interessanti applicazioni per i bambini a rischio didislessia (deficit di lettura) in cui la regione visiva per le parole (di sinistra) si attiva in modo atipico o insufficiente». Lo studio della musica all’inizio dell’alfabetizzazione svilupperebbe dunque un centro di analisi visiva simbolica anche a destra, che verrebbe poi utilizzato sia per le parole sia per le note.
Fonte: Ufficio Stampa Milano-Bicocca