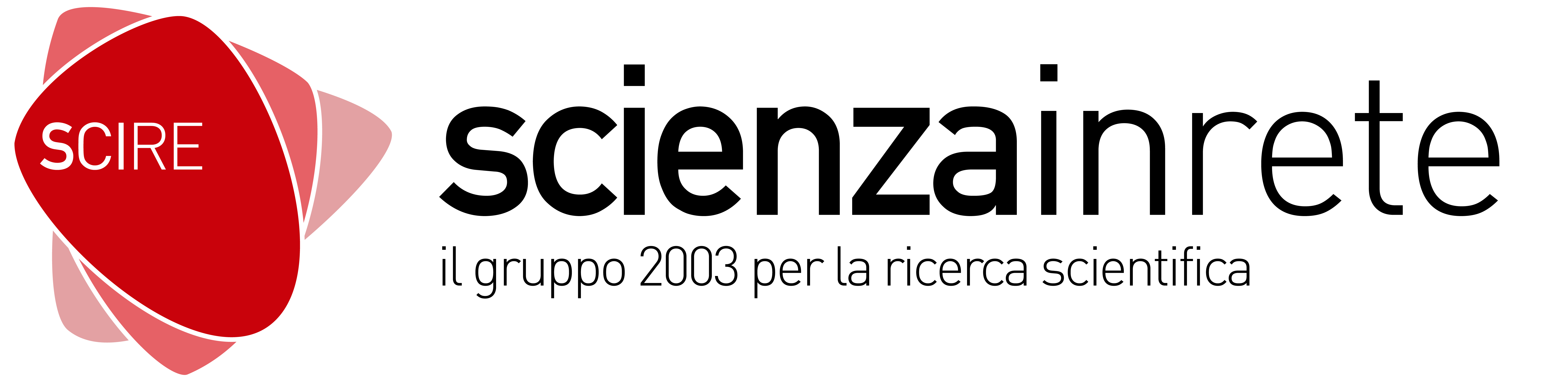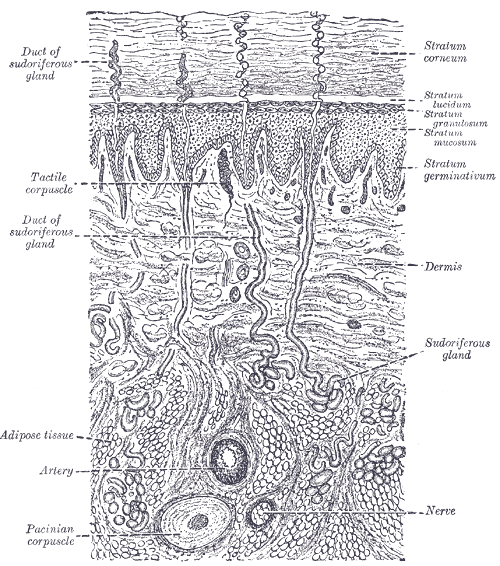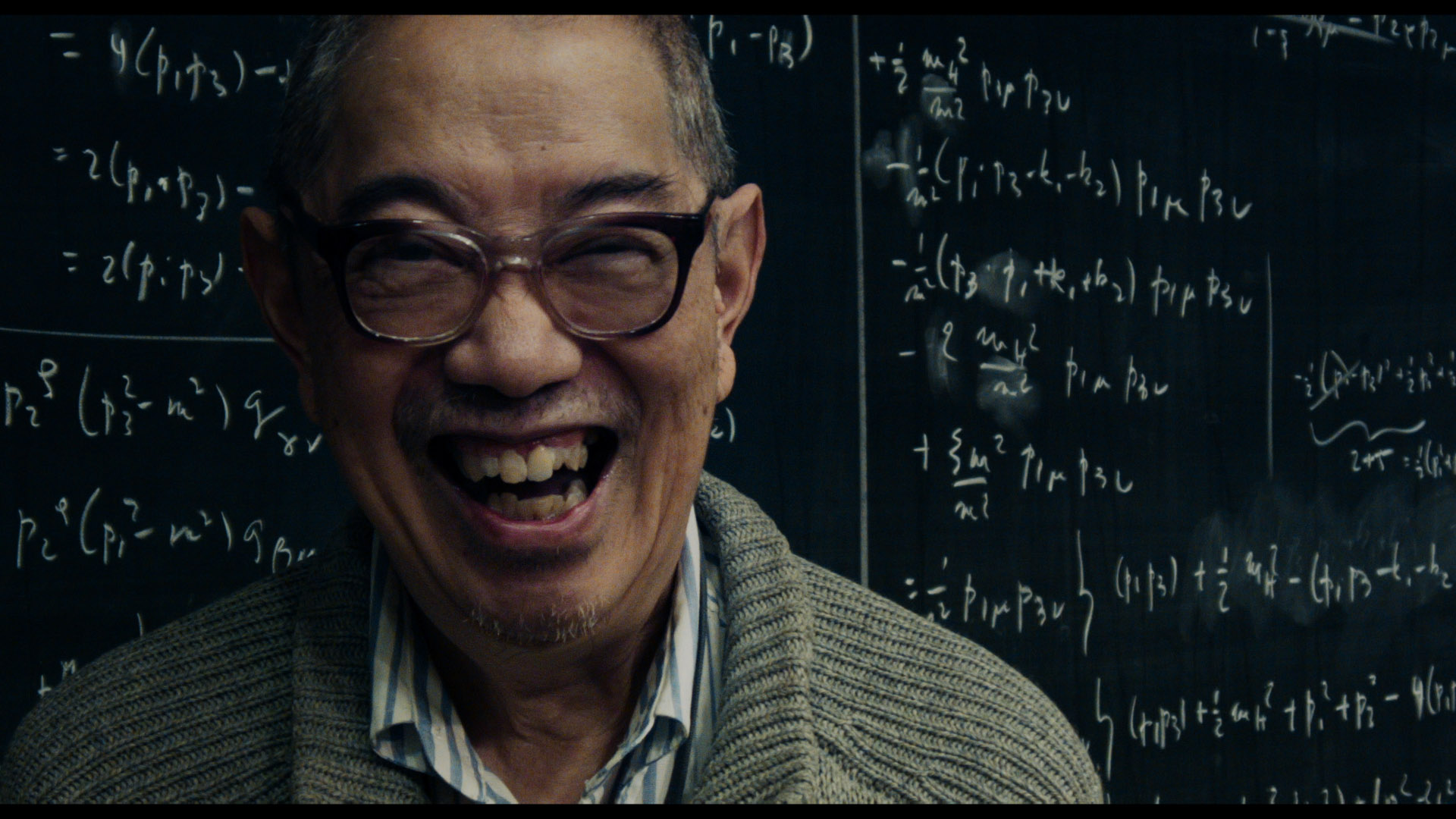|
newsletter #38
|
SKIN REGENERATION
|
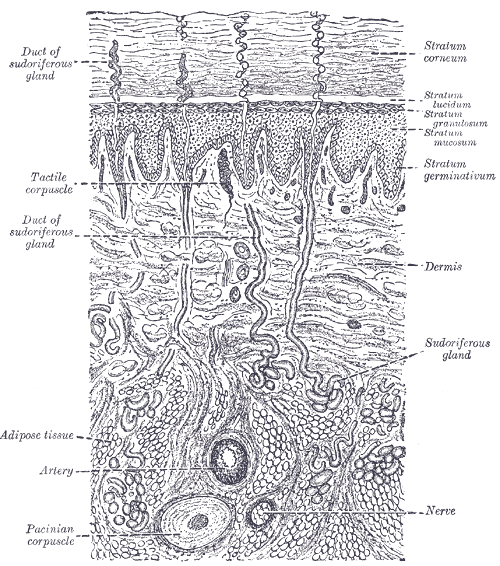 |
|
Una rappresentazione schematica
della sezione della pelle. L'immagine è tratta dal manuale di
anatomia del 1958 'Gray's
Anatomy', Tavola 940. Licenza: Public
Domain.
|
Un trapianto dell'80% della superficie
epidermica ha salvato un bambino di 9 anni
residente in Germania e affetto da una malattia
genetica, l'epidermolisi bollosa, che causa lo
sfaldamento dello strato superficiale della
pelle. I dettagli di questa scoperta sono stati
pubblicati sull'ultimo numero di Nature.
L'epidermide geneticamente corretta per il
trapianto è stata cresciuta nei laboratori della
Holostem Terapie Avanzate, una spin off dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
La società è stata fondata nel 2008 da Michele
De Luca e Graziella Pellegrini per rendere
utilizzabili nella pratica clinica le terapie
geniche sulle cellule staminali epidermiche
sviluppate e testate in un trial clinico
iniziato nel 2002.
[Nature; Editorial]
La Holostem Terapie Avzante è stata
la prima società a ottenere il via libera
alla commercializzazione di una terapia basata
sulle cellule staminali, la Holoclar. Il
trattamento può restituire la vista a
persone che hanno subito gravi ustioni della
cornea. Era il 2015 e Graziella
Pellegrini raccontava a Nature gli ostacoli
incontrati dal 1997, anno in cui i primi due
pazienti riottennero la vista, al momento
dell'approvazione da parte dell'agenzia europea
del farmaco.
[Nature; Alison Abbott]
|
|
|
COP23 A BONN
|
 |
|
Il World Conference Center a Bonn, dove dal 6
novembre sono in corso
i negoziati della ventitreesima conferenza delle parti della
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC). Credit: UNFCC
/ Flickr. Licenza: CC BY 2.0.
|
È in corso a Bonn la COP23, la ventitreesima
conferenza delle parti della United Nations
Convention on Climate Change
(UNFCCC). L'agenda dei negoziati si concentra
sugli aspetti operativi dell'applicazione
dell'Accordo di Parigi, dall'implementazione
della piattaforma assicurativa per risarcire i
Paesi maggiormente danneggiati, alla definizione
dei contributi nazionali. Gli Stati Uniti sono
presenti con due delegazioni: una ufficiale, che
rappresenta la posizione del governo
USA dopo la
decisione di Trump di abbandonare l'Accordo, e
l'altra che invece rappresenta la coalizione di
Stati e città che hanno intenzione di continuare ad applicare l’Accordo di Parigi.
[Climalteranti; Valentino Piana e Stefano Caserini]
L'urgenza del cambiamento climatico
riassunta da Le Monde in 10 numeri:
23 (le volte in cui le parti della UNFCC
si sono riunite), 2 °C (il tetto
fissato per l'aumento delle temperature rispetto
ai livelli pre-industriali), 30% (riduzione delle
emissioni necessaria entro il 2030), 100
miliardi di dollari (l'investimento annuale che i Paesi ricchi si sono impegnati a
fare fino al 2020), 30% (la perdita di
biodiversità attesa se le emissioni di gas
serra continuano al ritmo attuale),
400 ppm (la concentrazione media di
CO2 nell'atmosfera nel 2016), 7.8 (il
pH degli oceani nel 2100 se non riduciamo le
emissioni di CO2),
400 milioni (il numero di persone che vivono a
meno di 1 metro sul livello del mare), 1 metro
(l'innalzamento del livello degli oceani se l'aumento
delle temperature continua al ritmo attuale),
169 (i Paesi firmatari dell'Accordo, 170
includendo la Siria che lo ha sottoscritto il 7 novembre).
[Le Monde; Marianne Boyer e Paul Pichot]
Lorenzo Ciccarese dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale commenta il
recente rapporto dell'UNEP, il programma delle
Nazioni Unite per l'ambiente, sulle emissioni clima-alteranti, in particolare in relazione alle strategie di geo-ingegneria per ridurre il livello di gas serra in atmosfera.
[Scienza in rete; Lorenzo Ciccarese]
|
|
|
ETICA DELLA SCIENZA / POLITICA DELLA RICERCA
|
 |
|
Ministro Pop. Elaborazione di
Sergio Cima.
|
In vista del nuovo bando PRIN annunciato
dalla ministra Fedeli, il Gruppo 2003
ribadisce la necessità di istituire
un'Agenzia nazionale della ricerca che
garantisca la continuità dei finanziamenti, in
particolare alla ricerca di base. Il commento di Luca Carra.
[Scienza in rete; Luca Carra]
A settembre del 2016 Scienza in rete aveva
pubblicato una dettagliata analisi dei risultati
del bando PRIN 2015. Si
evidenziava che la maggior parte dei
fondi era stata assegnata a professori
ordinari (quasi il 70% nel settore
delle scienze della vita), che la maggior parte dei vincitori
erano maschi (quasi il 75% nel settore delle
scienze sociali e umanistiche, il meno
sbianciato) e, infine, che i progetti finanziati
coinvolgevano in media un numero di atenei piuttosto
elevato (nel settore delle scienze fisiche e dell'ingegneria più del 50% dei progetti coinvolge almeno 4 atenei).
[Scienza in rete; Chiara Sabelli]
|
|
|
MISCELLANEA
|
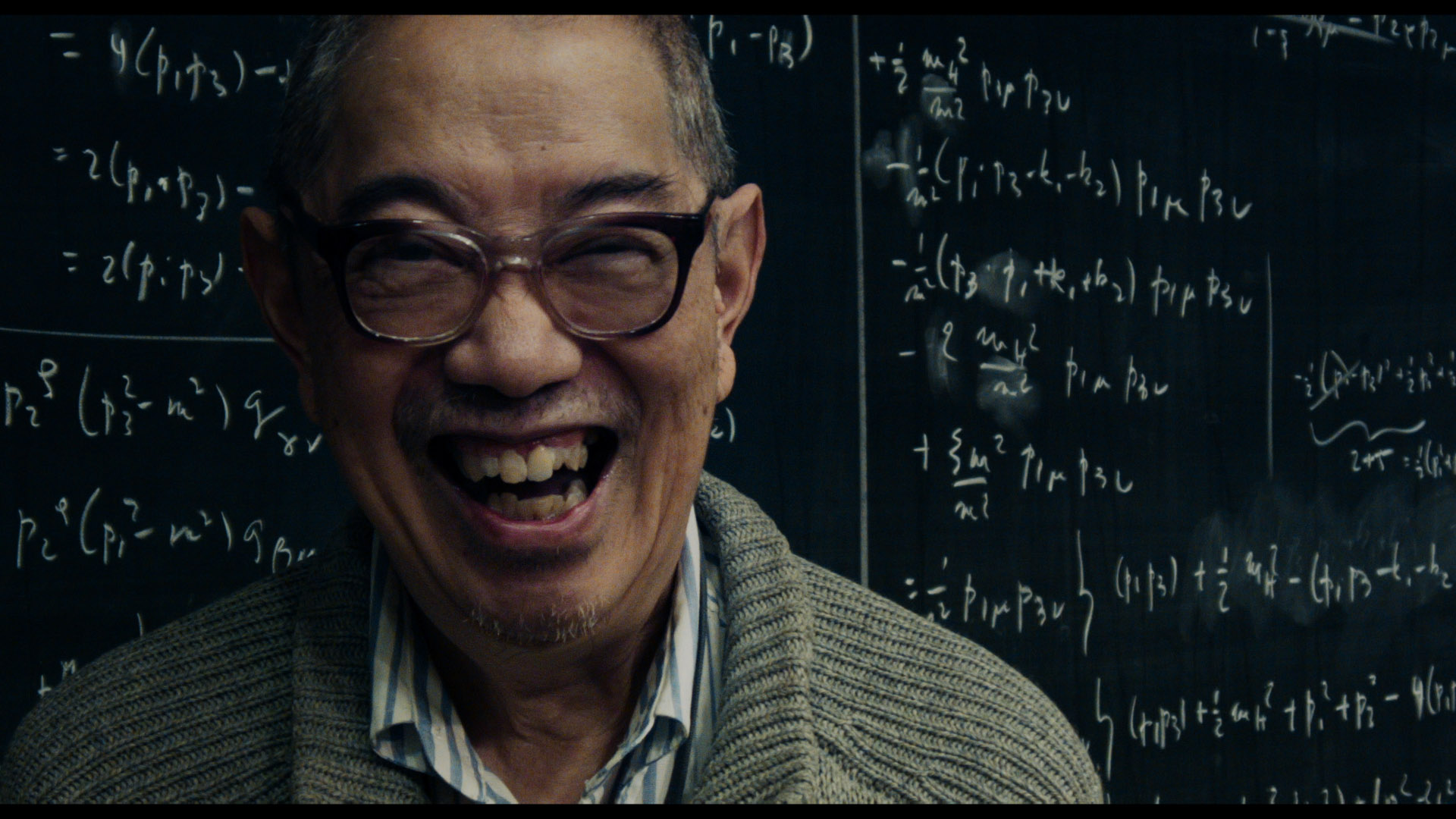 |
|
Il senso della bellezza. Arte e scienza al CERN. Un
film di Valerio Jalongo. Credit: AMKA Films.
|
Il 21 e 22 novembre prossimi verrà
proiettato nelle sale cinematografiche italiane
il film 'Il senso della bellezza - Arte e scienza al
CERN', di Valerio Jalongo. Quattro
anni dopo la sensazionale scoperta del bosone
di Higgs, il CERN è alla vigilia di un nuovo,
eccezionale esperimento. L’esperimento è insieme
un viaggio nel tempo più lontano e nello spazio
più piccolo che possiamo immaginare. Nel film
scienziati e artisti guidano lo spettatore verso quella linea d’ombra in cui scienza e arte, in modi diversi, inseguono verità e bellezza.
[Officine Ubu]
L'influenza dei social media nel dibattito pubblico potrebbe essere meno rilevante di quanto pensiamo, e il fenomeno delle filter bubble meno importante.
A concluderlo è un esperimento condotto da un
gruppo di ricercatori statunitensi di Harvard
University, Florida State University e
Massachusetts Institute of Technology, pubblicato sull'ultimo numero di Science.
Collaborando con alcune decine di piccole e medie testate giornalistiche, i ricercatori hanno coordinato l'uscita di una serie di articoli riguardanti temi politici, randomizzando le date di uscita su un arco di 5 anni. Ne hanno misurato poi l'impatto sul dibattito pubblico analizzando le discussioni generate su Twitter.
[Science; Matthew Gentzkow]
"A volte, i cacciatori di geni hanno successo,
sia pure tardivo": così, il premio Nobel per la
Fisiologia o la Medicina 2017 è stato attribuito
a tre ricercatori statunitensi settantenni,
Jeffrey C. Hall e Michael Rosbash,
dell’Università di Boston, e Michael W. Young,
dell’Università Rockefeller di New York, “per le
loro scoperte sui meccanismi molecolari che
controllano il ritmo circadiano”, descritte in
studi che hanno ottenuto il prestigioso
riconoscimento decenni dopo la pubblicazione." Il
racconto di Simonetta Pagliani.
[Scienza in rete; Simonetta Pagliani]
|
|
|
Segui Scienza in rete
|




|
|
Se non vuoi più ricevere la newsletter clicca qui
|
|
|
Con il sostegno di: |
 |
|
By: |
 |
|