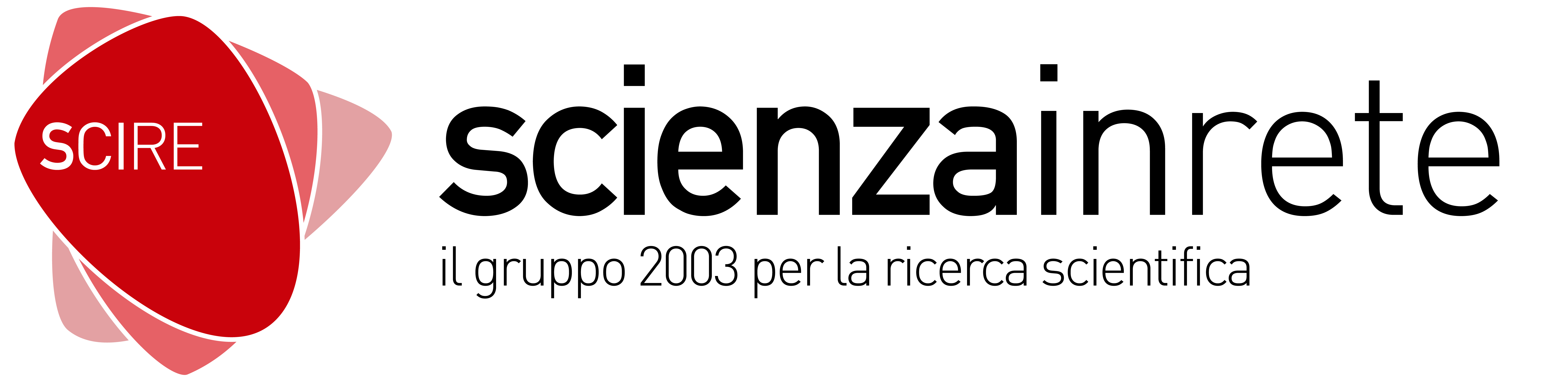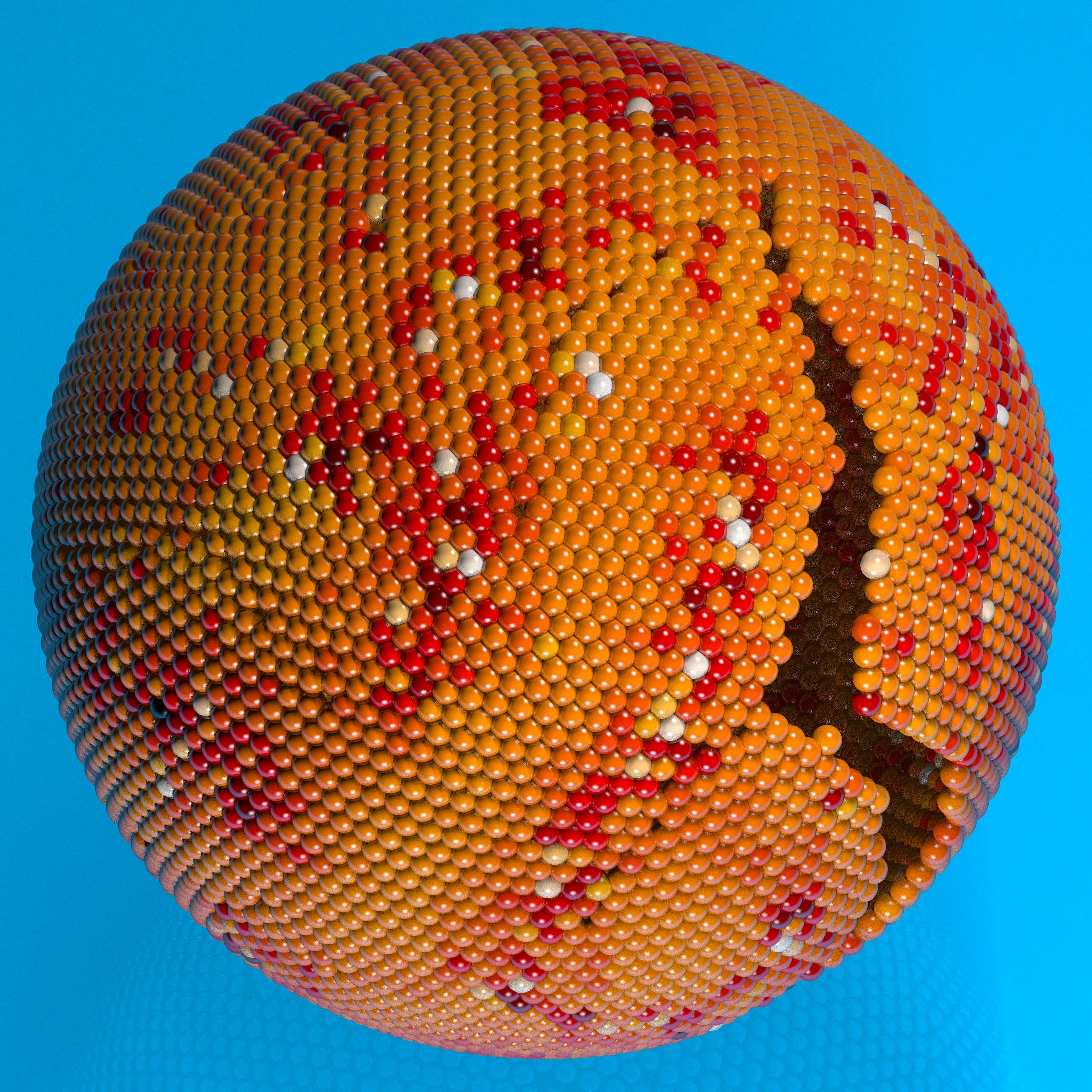|
newsletter #12
|
(FALSE) MEMORIE COLLETTIVE
|
 |
|
Credit: Ensuper / Flickr.
|
L'interazione tra persone
che condividono (o pensano di condividere) gli
stessi valori è favorita da internet e in
particolare dai social network.
Si formano così dei gruppi al cui interno
si instaurano dinamiche collettive che creano o
rafforzano notizie fake. L'insieme di tante piccole
notizie fake si somma a formare una “memoria collettiva
alternativa”.
La conversazione di Brian Resnick, reporter di Vox, con Henry L. Roediger, direttore del Memory Lab alla Washington University in St. Louis.
[Vox; Brian Resnick]
I ricordi collettivi contribuiscono a costruire
l'identità di un popolo. Il periodo dal
1849 al 1949 è conosciuto dai cinesi
come il “secolo dell'umiliazione”. L'11
settembre è il ricordo collettivo
più forte per gli Stati Uniti
contemporanei. Ma come si modifica questa
memoria di comunità? Cosa succede quando un
popolo o un gruppo sociale cancella un ricordo
collettivo? Uno studio, che si è esteso
dal 1974 al 2009, ha provato a capire quanto
velocemente vengono dimenticati i presidenti
americani e perché.
[Scientific American; Henry L. Roediger III e
Andrew DeSoto]
Cosa sono le fake news? Notizie “false” o notizie “finte”? Una
riflessione sulle differenze tra distorsioni,
filtri e censure operate dai mass-media e dalle
fonti di informazione istituzionali.
[lavoce.info; Riccardo Puglisi]
|
|
|
NUOVA MOBILITÀ
|
 |
|
Credit: Hiroko Masuike/The New York Times.
|
Nel 2001 il cittadino americano medio ha passato 161 minuti al giorno in macchina, percorrendo 134
km a una velocità media di 44
km/h. L'introduzione dei servizi di guida su
chiamata, come per esempio Uber, ha peggiorato la
situazione del traffico nelle aree urbane. A New York
nel 2016 è stato registrato un calo nell'utilizzo
dei trasporti pubblici, soprattutto nel
fine-settimana. Le self-driving cars potrebbero
peggiorare le cose: più persone potranno
spostarsi in macchina autonomamente (come anziani e bambini)
e più persone “vorranno” spostarsi in
macchina, visto che il tempo nel traffico
potrà essere usato per lavorare o
sbrigare altre faccende.
[Fortune; Stephen Gandel]
La capacità di raccogliere dati
sulla mobilità e analizzarli in tempo
reale è un approccio alternativo per
ottimizzare i tempi di percorrenza in
automobile, con un guadagno in termini di
consumi, e quindi di impatto ambientale, e di
qualità della vita.
I modelli matematici del traffico sono stati
inizialmente formulati sfruttando la somiglianza
dello scorrimento delle auto lungo una strada
con il movimento di un fluido. La
disponibilità di dati ha cambiato molto
questo approccio, permettendo anche di simulare
reti stradali estese.
[Scienza in rete; Roberto Natalini]
Le self-driving cars e l'analisi sofisticata dei
dati di mobilità sono entrambi tentativi di aumentare la
“capacità” di trasporto della rete
stradale. Secondo uno studio di due economisti
statunitensi, pubblicato nel 2011 sull'American
Economic Review, questo approccio è
destinato a fallire. Esiste infati una
fundamental law of road congestion, per
cui qualsiasi aumento di capacità
stradale produce un aumento nel numero di km
percorsi in auto. Sia in autostrada che nelle
aree urbane. L'unico modo per affrontare il
problema del traffico è introdurre dei pedaggi variabili
secondo l'orario. In alcune città questa
strategia ha funzionato, negli USA non è
ben accetta. Almeno finora.
[The Upshot - The New York Times; Conor Dougherty]
|
|
|
ETICA DELLA SCIENZA / POLITICA DELLA RICERCA
|
 |
|
|
Cristina Da Rold si concentra sui risultati dell'ultimo rapporto ANVUR sulla qualità della ricerca dei dipartimenti di filosofia in Italia, settore per settore.
Complessivamente i risultati sono positivi e mostrano come anche in area filosofica si stiano sviluppando competenze sempre più specialistiche.
[Scienza in rete; Cristina Da Rold]
La riflessione di Francesca Pasinelli, direttrice generale della FONDAZIONE TELETHON, sui metodi di valutazione dell'ANVUR.
Tre i punti fondamentali: usare con cautela la bibliometria, organizzare degli incontri negli istituti di ricerca sottoposti a valutazione, stimare l'impatto sulla società non solo in termini di spin-off e brevetti.
[Facciamoci un pensamento; blog di Francesca Pasinelli]
Dal 2009 sono attivi in Italia corsi
universitari di medicina in inglese. Alcuni tra
i primi laureati hanno trovato posto nei
programmi di specializzazione svizzeri, tedeschi
e britannici. E intanto cresce il numero di
studenti stranieri che si iscrivono ogni anno. Erik Campano fa un primo bilancio su questa iniziativa.
[Scienza in rete; Erik Campano]
Il 29 marzo il primo ministro inglese Theresa
May ha avviato il processo di negoziazione che in due anni
condurrà la Gran Bretagna fuori
dall'Unione Europea. Uno degli obiettivi del
governo inglese è di mantenere il legame
con la ricerca scientifica europea e con i suoi
programmi di finanziamento, da cui finora la
Gran Bretagna ha ottenuto 7 miliardi di euro. Ma
resta da capire che livello di priorità
avrà questo argomento nel lungo percorso
diplomatico appena cominciato.
[Science; James Wilsdon]
I San, la popolazione indigena che abita il
deserto del Kalahari tra Sudafrica, Namibia e
Botswana, ha recentemete pubblicato un codice
etico che i ricercatori, soprattutto genetisti, interessati a studiare
alcune loro caratteristiche dovrebbero
seguire. Il primo codice etico della ricerca su
popolazioni indigene è stato redatto nel
2012 da parte delle comunità aborigene
australiane. Quello proposto oggi dal popolo San
è il primo in Africa.
[Nature; Ewen Callaway]
|
|
MISCELLANEA
|
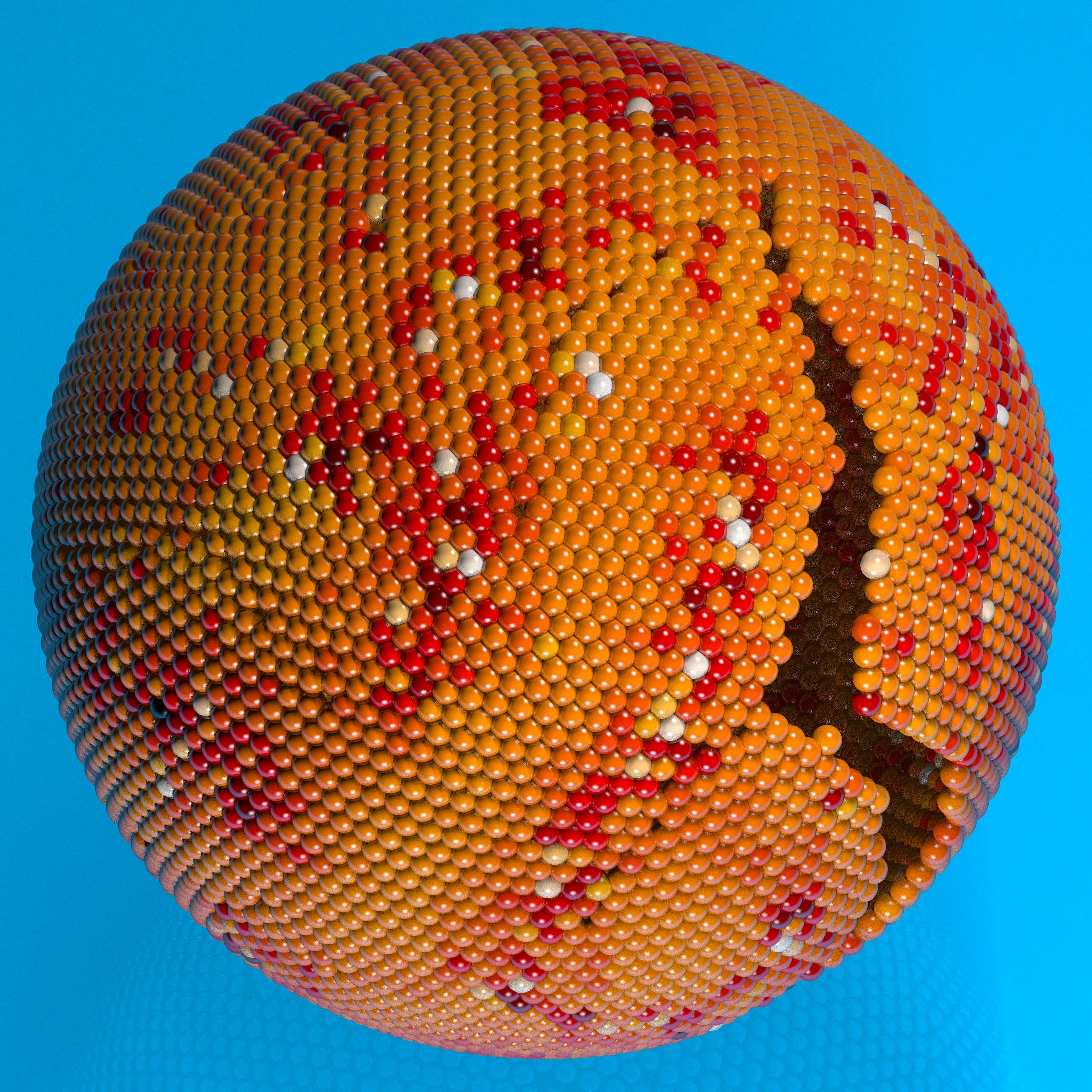 |
|
Simulazioni di un cristallo
colloidale su di una superficie sferica. Cambiando la
forma e il volume della superficie il cristallo si
deforma e si frattura. Dall'articolo "Deformation and
failure of curved colloidal crystal shells" pubblicato
su PNAS vol. 112 no. 47, pp. 14545–14550.
|
Capire come si rompono i materiali, dalla scala nano-metrica fino a quella dei chilometri, lungo cui si estende un ponte ad esempio.
Questo è l'obiettivo del progetto SIZEFFECTS, coordinato dal fisico teorico Stefano Zapperi della Università degli Studi di Milano, finanziato nel 2011 con un Advanced Grant dello European Research Council.
[Scienza in rete; Michele Bellone e Luca Carra]
Una simbiosi, intesa come rapporto di
convivenza fruttuosa, tra essere umano e
macchina. Questa è la suggestione da cui
parte Il crepuscolo dei simbionti,
dramma di fantascienza dell'ingengnere
elettronico e scrittore Giuseppe O. Longo,
andato in scena al Museo Revoltella di Trieste
in occasione della Settimana del
cervello. In questa intervista Giuseppe
O. Longo esprime il suo punto di vista sul
rapporto tra noi umani e l'intelligenza
artificiale, delineando possibili scenari futuri.
[MCS TV; Alessia Lodola e Fosca Pescia]
L'ultimo romanzo di Giuseppe O. Longo è intitolato La gerarchia di
Ackermann. Gianni Zanarini lo ha letto per
Scienza in rete.
[Scienza in rete; Gianni Zanarini]
In occasione della Settimana del cervello Enrico Tonin, professore di microbiologia
all'Università di Trieste, ha parlato dei
vaccini contro le malattie del sistema
nervoso. Il punto in questa intervista.
[MCS TV; Sara
Mohammad, Anna
Romano e Giulia Virtù]
Il 21 marzo l'accademia norvegese della scienza e letteratura ha assegnato il premio Abel 2017 a Yves Meyer, il matematico francese che ha contribuito a fondare la teoria delle wavelet.
Si tratta di uno strumento potentissimo per l'analisi dei segnali e ha ormai applicazioni nei campi più diversi: dalla compressione delle immagini JPEG alla scoperta delle onde gravitazionali.
[Quanta Magazine; Natalie Wolchover]
L’incanto e il disinganno: Leopardi è il titolo del saggio
pubblicato da Guanda Editore scritto dal genetista Edoardo Boncinelli
e dal filosofo Giulio Giorello. Valentina Sordoni lo ha letto e recensito per Scienza in rete
[Scienza in rete; Valentina Sordoni]
|
|
|
Segui Scienza in rete
|




|
|
Se non vuoi più ricevere la newsletter clicca qui
|
|
|
Con il sostegno di: |
 |
|
By: |
 |
|